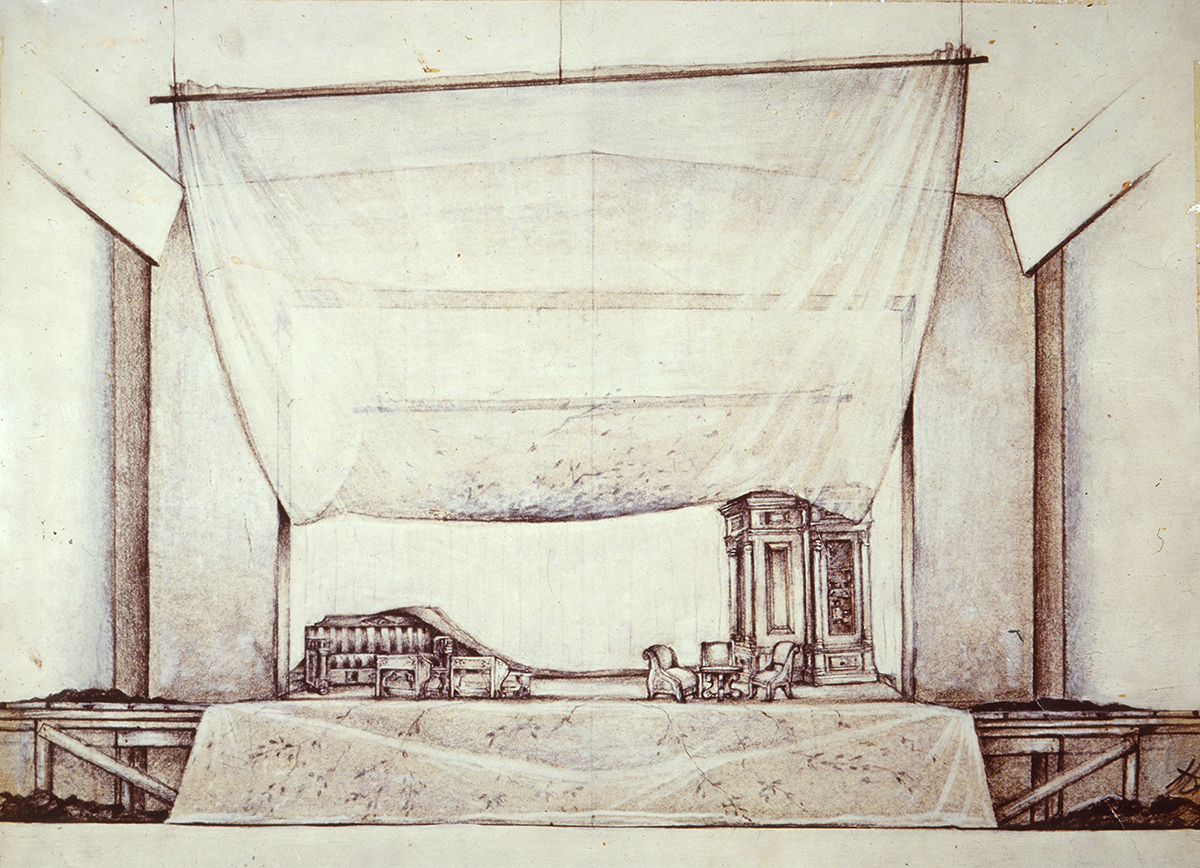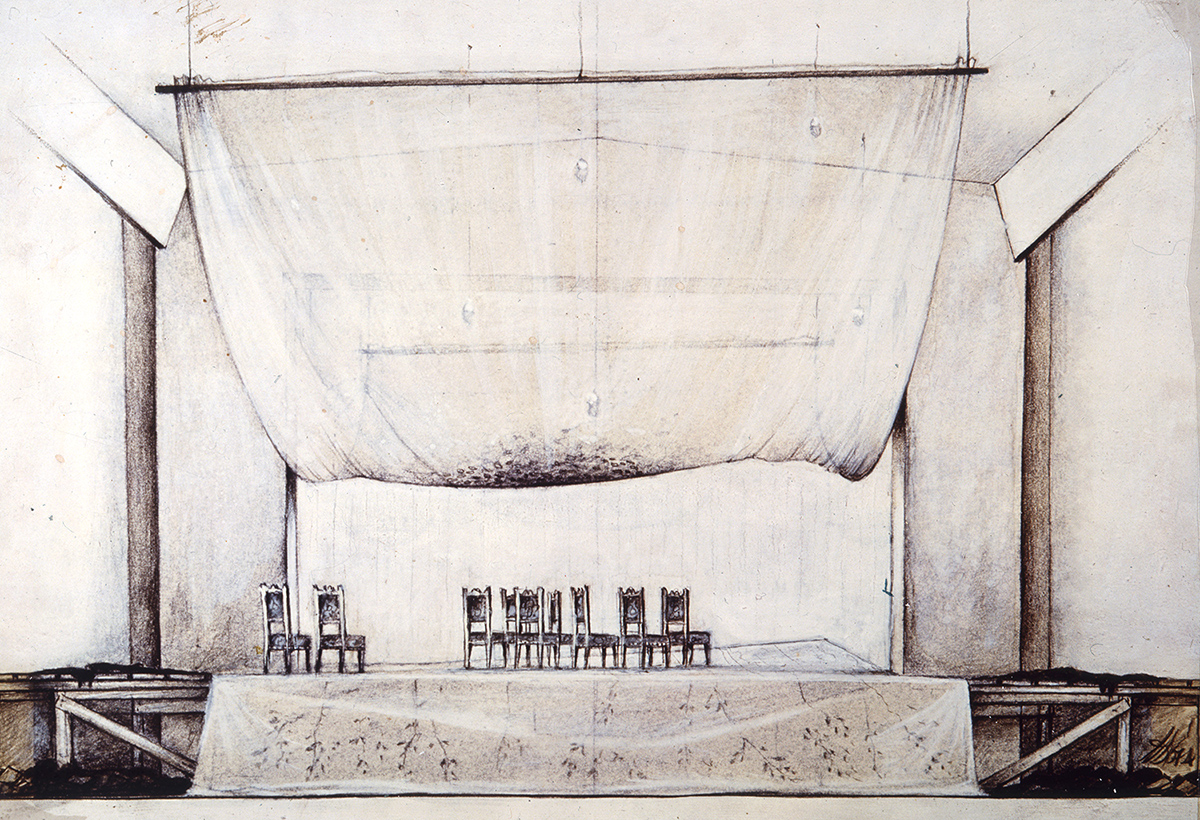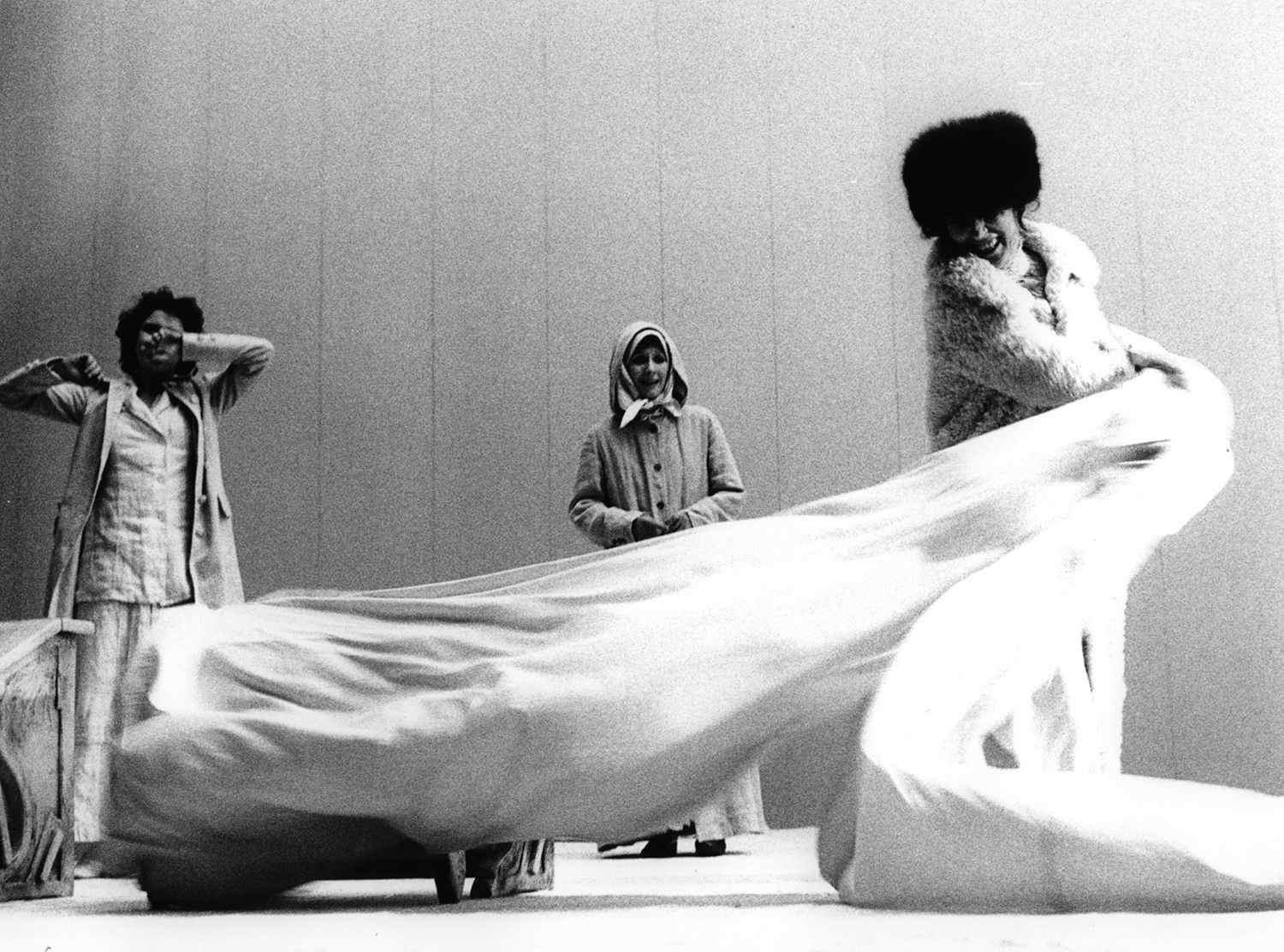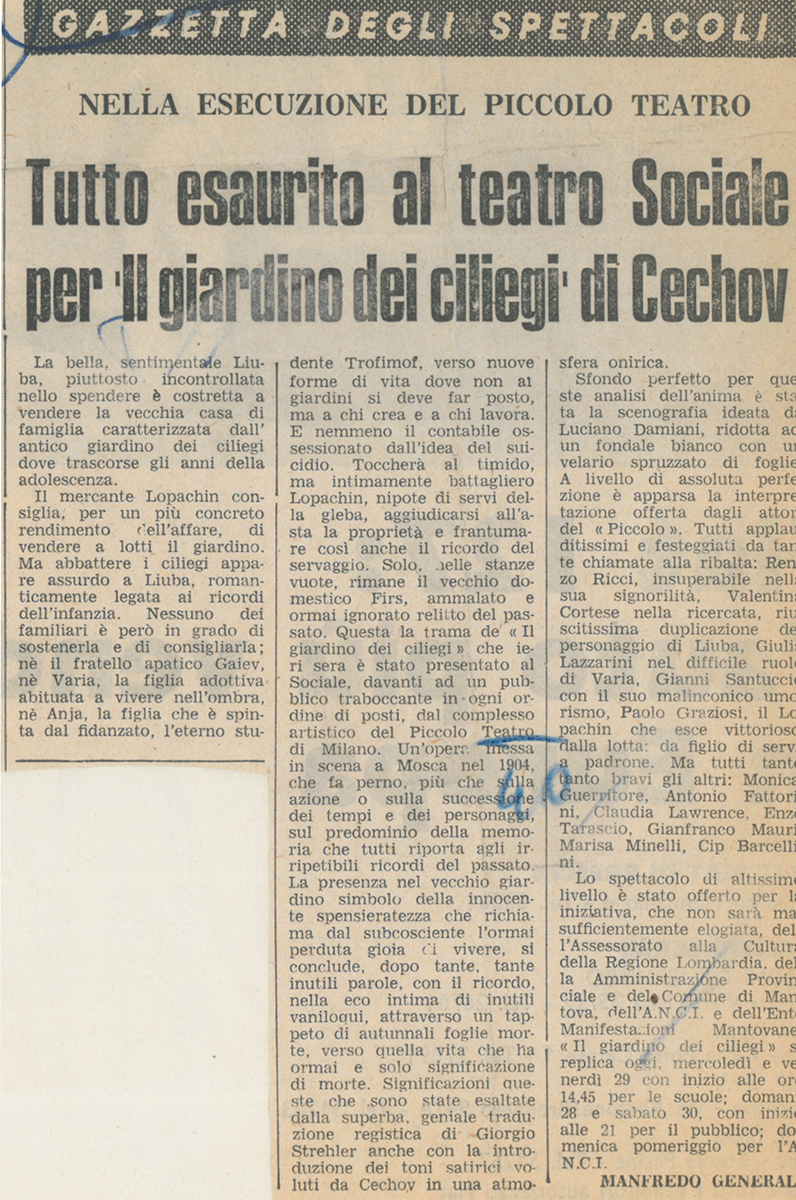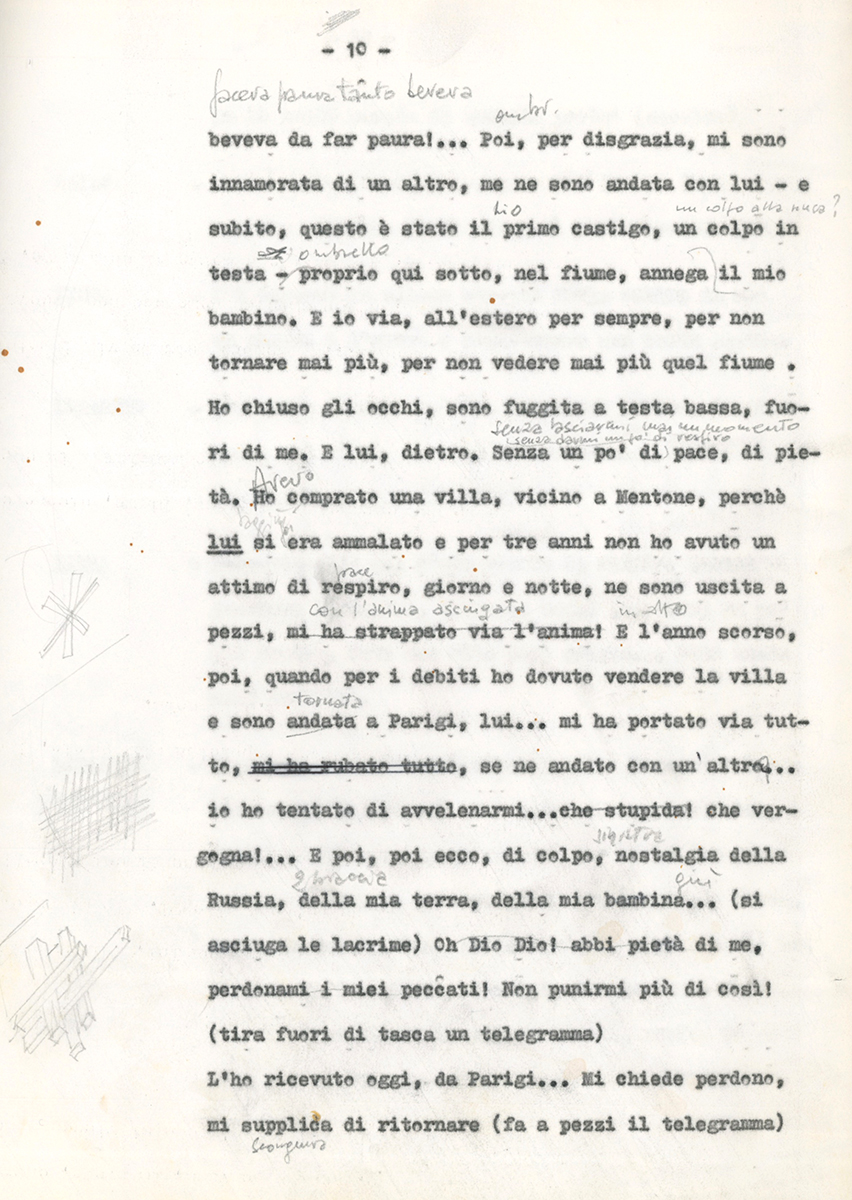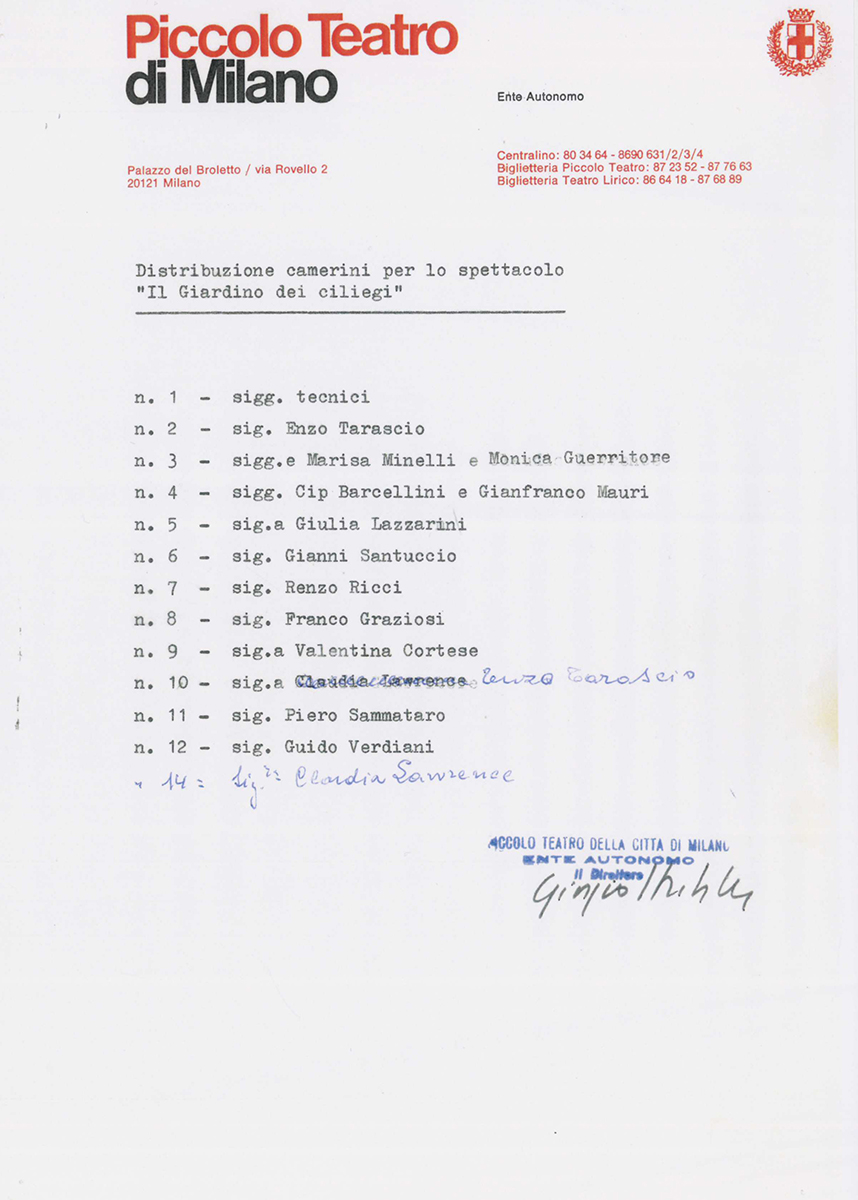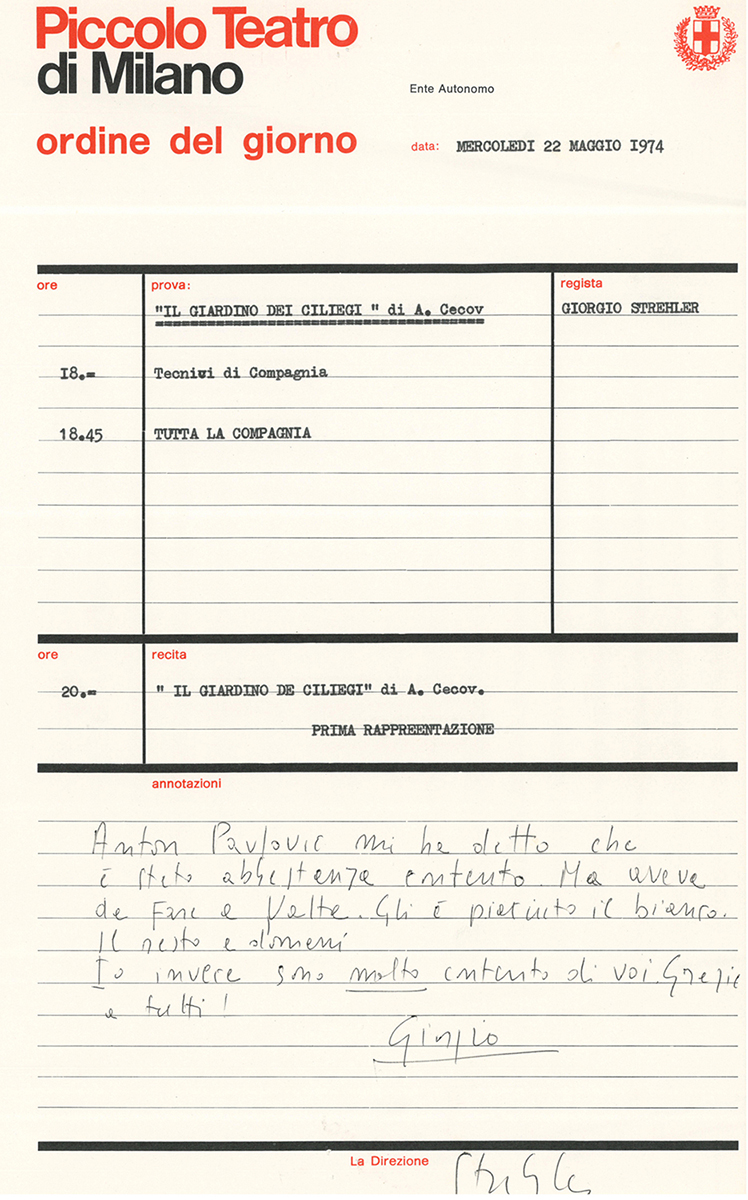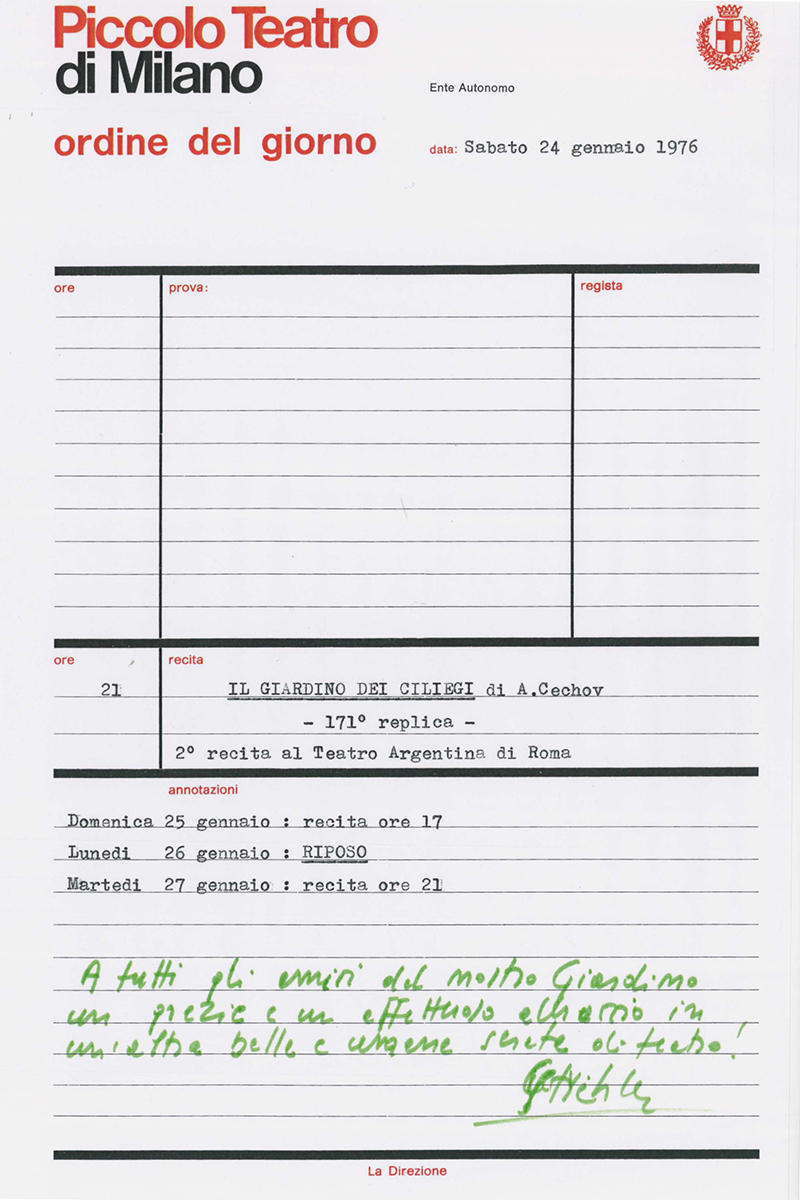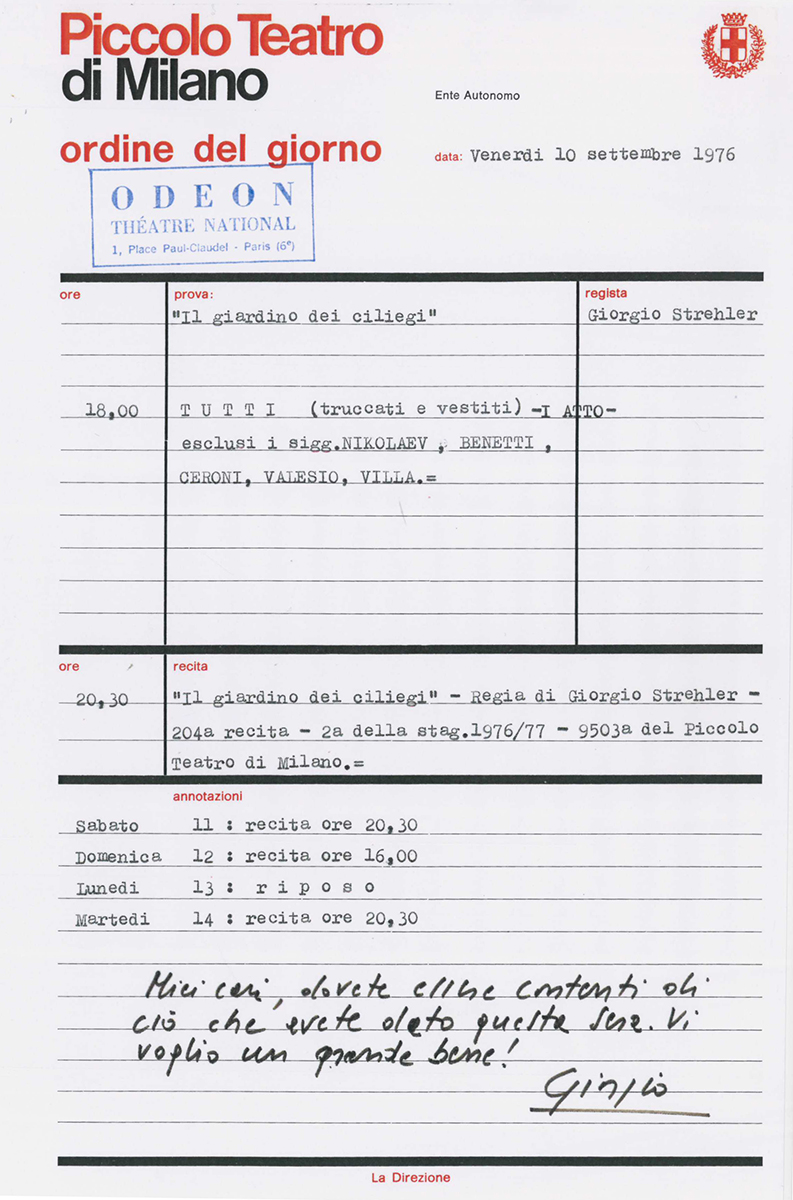Un chiaro, candido velario dal fondo della scena sale all’arco della ribalta e da lì si protende sul soffitto della sala, palpita e ondeggia sul capo degli spettatori come una cupola di luce, qua e là inscurita appena da tenere foglioline che talvolta, quando un fremito o un presagio di tempesta percorre quel cielo, calano sfarfallando con capricciosa lentezza. Il giardino dei ciliegi di Čechov, secondo Strehler e Damiani, si racchiude in questa immagine, che è anche una chiave poetica: un giardino che non c’è, eppure c’è; e respira sulla spoglia, bianca scenografia: neve, sole, vento, luce, fruscio e simbolo. Il grande velario di tulle bianco che, alla fine, si ritrae nelle ombre della casa abbandonata, mentre le foglie di quell’ultimo autunno hanno ancora un tremito, non è, però, qui solo il simbolo del candore del giardino, ma anche un sudario che si rattrappisce sulle cose, che si abbatte sulla nera sagoma del vecchissimo Firs, il servitore rimasto avvinghiato alle radici di un’età ormai giunta alla fine.
Ma perché il Giardino diciannove anni dopo la prima versione? Per rispondere a questa domanda non basta il bisogno – sempre molto sentito da Strehler – di presentare alle nuove generazioni, del tutto ignare della versione precedente, un capolavoro della storia del teatro. Perché qui Strehler non ripete affatto l’edizione del 1955. Il problema, semmai, è interno, teatrale: superare il naturalismo (presente nella prima versione) e, dunque, ripensare l’insegnamento di Stanislavskij.
Il regista affronta il problema scacciando il superfluo e muovendo da una suggestione ricevuta proprio da Čechov: «Un giardino in fiore, tutto bianco, e signore in bianco che vi passeggiano dentro». Anche il lavoro sugli attori è tutto in levare, e Strehler elimina la retorica per portare sulla scena un clima astratto e magico, creato dai personaggi come proiezioni dei loro stati d’animo e della loro condizione. Provocata dal regista, esplode una figuratività limpida e asciutta, di costante, puro lirismo. È la poesia totale del teatro, la sua parola onnicomprensiva; sono l’evocazione e il sogno, il brivido dell’universo, il riso e – insieme – le lacrime delle cose.
Il giardino dei ciliegi
1974
Personaggi e interpreti
Liuba Valentina Cortese
Ania Monica Guerritore
Varia Giulia Lazzarini
Gaief Gianni Santuccio
Lopachin Franco Graziosi
Trofimof Piero Sammataro
Piscik Enzo Tarascio
Charlotte Claudia Lawrence
Iepicodof Gianfranco Mauri
Duniascia Marisa Minelli
Firs Renzo Ricci
Iascia Cip Barcellini
Un viandante Vladimir Nikolaev
Un invitato Guido Verdiani
[I nomi dei personaggi sono riportati con la grafia impiegata nelle locandine originali dello spettacolo]
Scene e costumi di Luciano Damiani
Musiche di Fiorenzo Carpi
Registi assistenti Carlo Battistoni, Enrico D’Amato, Lamberto Puggelli
Testo di Anton Čechov
Traduzione di Luigi Lunari e Giorgio Strehler
Regia di Giorgio Strehler
Milano, Piccolo Teatro, 22 maggio 1974
Riprese
- 1974-1977
A partire dal dicembre 1974 lo spettacolo è ripreso a Milano.
L’anno successivo, Il giardino dei ciliegi è nuovamente a Milano (ma al Teatro dell’Arte) e a Genova.
Nel 1976 va in scena a Prato, Roma, Parigi, Modena, Mantova, Lecco, Torino e Bergamo, per poi completare la sua tournée, nel 1977, a Carpi, Pavia e Milano.
In alcune recite, il ruolo di Varia è interpretato da Relda Ridoni; quello di Gaief da Renato De Carmine; quello dell’Invitato da Armando Benetti.Il 24 e 25 marzo 1978 la Rai trasmette lo spettacolo registrato nel maggio 1977, al Teatro Comunale di Carpi, con la seguente distribuzione:
Liuba Valentina Cortese
Ania Monica Guerritore
Varia Giulia Lazzarini
Gaief Renato De Carmine
Lopachin Franco Graziosi
Trofimof Antonio Fattorini
Piscik Enzo Tarascio
Charlotte Claudia Lawrence
Iepicodof Gianfranco Mauri
Duniascia Marisa Minelli
Firs Renzo Ricci
Iascia Cip Barcellini
Un viandante Vladimir Nikolaev
Un invitato Armando Benetti[I nomi dei personaggi sono riportati con la grafia impiegata nelle locandine originali dello spettacolo]
Scene e costumi di Luciano Damiani
Luci Giampiero Puliti
Musiche di Fiorenzo Carpi
Regista collaboratore Carlo BattistoniTesto di Anton Čechov
Traduzione di Luigi Lunari e Giorgio StrehlerRegia di Giorgio Strehler
Strehler ne parla
- La stanza dei bambini: un cimitero del tempo
14 gennaio 1974
Nella camera dei bambini del primo atto ci sono “le cose” che appartenevano all’infanzia di Liubov e Gaiev. Le battute di Liubov non lasciano dubbio in proposito. L’indicazione di Čechov è: la camera che è “ancora” chiamata la camera dei bambini. E in quell’“ancora” è racchiuso, con estrema densità, il senso che probabilmente Čechov voleva dare a tutto l’ambiente-scena-racconto-situazione.
La chiamano “ancora” dei bambini, quella stanza, ma non è più dei bambini, perché “bambini” non ce ne sono: l’ultimo è morto cinque anni prima ed era il bambino di Liubov. Ania ha “la sua stanza”, anche se è ancora quasi bambina, ma l’infanzia vera e propria è finita in quella stanza, appartiene al passato. In realtà la stanza era solo quella dei bambini Gaiev e Liubov.
Così credo sia necessario individuare alcune “cose” tipiche rimaste: cioè plausibili, ma che abbiano la stessa risonanza della “didascalia”. Infatti, se noi osserviamo le “scene” delle diverse edizioni del Giardino, da quella del 1904 all’ultima di Visconti, tra le quali c’è anche quella di Giorgio Strehler, in tutti i paesi, compresa la Cecoslovacchia, che sembra abbia oggi un poco il monopolio della “riscoperta” di un Čechov “diverso” da Stanislavskij, ci accorgiamo che, se non lo si dice, nessuno può capire che quella “era” ed “è”, nonostante tutto, la camera dei bambini.
Si vede una “stanza” qualsiasi, più o meno ben fatta, più o meno realistica o semplicizzata, ma il sentimento plastico dell’infanzia non c’è. È probabile che la stanza sia stata usata, nel tempo, dopo i bambini, come camera di passaggio. Infatti i personaggi passano, entrano quasi per caso nella stanza. Liubov dorme altrove, Gaiev anche, Ania pure.
La stanza non serve più. E può essere una specie di vasta anticamera spoglia, ma che porta la traccia dei bambini di un tempo. Qualche mobile rimasto immobile, mentre i bambini sono diventati vecchi. Due banchi di scuola, piccoli, dipinti di bianco. Là, i “bambini”, fratello e sorella, facevano i compiti, un tavolino laccato, nano, e qualche seggiolina e due poltroncine per un salottino “da gioco”. Uno scaffale con la lanterna magica a petrolio e qualche giocattolo restato lì, per caso. E un servizio per giocare alla cucina o al “pranzo” di Liubov. Una piccola bilancina di latta per “giocare al commercio”, la credenzina con i cassettini per le spezie e un servizio da caffè e tè, minuscolo. Ma c’è anche un divanone per grandi. E c’è un armadio-mamma, da un lato, grandissimo, bianco, a specchio dentro, semplice, ma misterioso.
Gaiev e Liubov ritroveranno, a poco a poco, la loro infanzia perduta non “soltanto” guardando il giardino nell’alba. Ma vivendo tra i fantasmi rimasti di un’infanzia sepolta. Finiranno anche per sedere nei banchi, a malapena, rannicchiati, e parlarsi così. Gaiev si sporcherà le dita d’inchiostro come una volta e Liubov peserà lo zucchero con la bilancina e verserà un po’ di tè o caffè nelle tazzine e giocherà con se stessa e con Gaiev, servendo tutto su una guantierina di latta dipinta. Siederanno anche intorno al tavolino nano, per un gioco impossibile che culminerà con lo spalancarsi dell’armadio che incautamente Gaiev avrà battuto e poi aperto girando la chiave, nel suo sermone sul passato.
Perché dentro l’armadio c’è troppa roba stipata, alla rinfusa, che precipiterà in scena come una tenera e lancinante valanga, con polvere e strass e piume e cappelli e veli e nastri e scarpe e scatole e marinarette blu e tanto tanto altro, scatole con palle di natale che rotolano e poi si rompono, carte e lettere e infine la carrozzina cromata di tela cerata nera, come una piccola bara che correrà da destra a sinistra sull’avanscena, per poi investire Liubov, ignara ancora che si trova la carrozzina del suo bambino, addosso.
E allora, là, Liubov piangerà in silenzio. E la stanza apparirà allora come una specie di cimitero del tempo in cui invano Varia e anche Liubov e Gaiev poi, durante una parte della scena, tenteranno di mettere ordine. Senza riuscirci. Forse finiranno per sedersi per terra sui vecchi vestiti, cappotti e una coperta di pelo, una volta bellissima, ora smunta, ma ancora morbida da accarezzare e farvisi su dentro. E Ania si addormenterà così, o in mezzo a tanto passato, anche lei a terra, dolcemente, o su un banco piccolo di scuola, senza accorgersi quasi, e si farà portar via così, mentre la luce invade quel terribile e dolce vuoto.15 gennaio
Il primo atto: la camera dei bambini, i mobili da bambini, i banchi di scuola, dove Gaiev e Liubov hanno fatto i compiti, e il grande armadio-mamma-memoria, pieno di tutta una vita, o tante vite. La carrozzina nera, di tela cerata e cromata, del bambino morto, che rotola fuori per prima quando Gaiev nella sua predica batte l’armadio con le mani e ne apre le ante. Dall’armadio esce la carrozzina che, traballando, rotola e si ferma dalla parte opposta, vicino a Liubov, e scendono, precipitano fuori, valanghe di cose, scarpe, un abito da marinaretto con cappello coi nastri, e impermeabili, e mantelli, e sacchi, e libri, e fogli di carta, e cappelli, e tanto altro: il cimitero delle vite che passano.
Nel secondo atto: un fondale, lontano, e il trenino-giocattolo che percorre il fondale da una parte all’altra, poi esce in quinta e rientra alla ribalta, rientra in quinta e riappare nel fondale, con piccole luci e vagoni di latta e la carica meccanica, e traballa a metà tra giocattolo e memoria anche lui, e finzione. Quando passa nel fondo, quasi invisibile, tra le montagne del fondale meravigliosamente dipinte, o la pianura meravigliosamente dipinta. I protagonisti giocano e non giocano ancora con l’oggetto dell’infanzia, in un vuoto ove le parole risuonano… Sull’avanscena, il mistero di quel giardino che non c’è e scende fino in platea. Un sipario di luce attraverso il quale si vede tutto lo spettacolo.
Un’atmosfera luminosa, mobile, impalpabile; e nello stesso tempo quasi densa, di polvere e sole e luna e vento, che muta e diventa notturna, e alba, che diventa ora lirica, ora tragica e cupa. Se un telo grande e semplice scendesse dal palco giù nella platea, come steso su un terreno morbido, un ondeggiare di colline (forse il monte verde e scuro dei Giganti), portato davanti e fin giù…21 gennaio
L’idea di Čechov di far svolgere il primo e l’ultimo atto del Giardino nella “camera dei bambini” non è casuale. Né lo è l’armadio, in quella stanza. È strano che nessuno abbia mai dato l’importanza che merita a questa evidente figura-simbolo: l’armadio di cent’anni. A mio avviso l’idea dell’armadio, oggetto reale e plastico, e simbolo appunto, integra perfettamente l’idea della “camera dei bambini”, e cioè dei giochi di una età ormai favolosa per i “vecchi”. Proietta nella camera dei bambini (oggetti, cose) un altro oggetto-cosa che prolunga il tempo della stanza. Cioè, nella stanza dei bambini ci sono dei vecchi, e nella stanza c’è anche una cosa ancora più vecchia, che rimanda ancora più indietro, ancora più indietro di Firs, che è il più vecchio.
L’armadio è qualcosa di intermedio fra la gente che agisce e il giardino, vero e presupposto o simbolico, che è antichissimo. Il gioco del tempo viene così potenziato dall’armadio e ancora non è un caso che Gaiev faccia quel lungo discorso proprio all’armadio. I due termini, insomma, sono in una posizione plastico-dialettica di enorme efficacia, purché di questo armadio si riesca a fare qualcosa di più di una presenza relativa.
Non dimentichiamo che Čechov, ad esempio, dice in didascalia: «Varia apre l’armadio, che scricchiola».Čechov non scrive mai una didascalia a caso. Qui c’è dunque un’indicazione comica, di una cosa “antica”, penosa, che fa fatica, che evoca il senso del tempo, e tanto altro.
Dagli appunti di regia, pubblicati nel programma di sala e, con tagli, in Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, a cura di Sinah Kessler, Milano, Feltrinelli, 1974; ripubblicati, in seguito, nell’edizione BUR de Il giardino dei ciliegi, a cura Luigi Lunari, 1975
- Le tre scatole cinesi
29 gennaio 1974
Il problema del “giardino” è fondamentale. Nessuno di noi è riuscito mai a rendere poeticamente, simbolicamente e plasticamente questo giardino, che rappresenta forse troppe cose insieme per poter essere “rappresentato”, almeno sulla falsariga del naturalismo, poi diventato realismo “poetico”. Le strade scelte o tentate da Svoboda e altri, cioè di una astrazione simbolica non solo del giardino, ma di tutte le scene e di tutto Čechov, hanno certo ottenuto talvolta risultati interessanti e anche pregnanti poeticamente. Ma il problema è stato, per così dire, aggirato.
Nonostante tutto, quando il vecchio Pitoëff rappresentava il Giardino in un panorama di velluto grigio con pochi mobili, e diceva che Čechov era solo “atmosfera di parole”, faceva la stessa operazione, con maggiore ingenuità ma anche con minore presunzione. In realtà, noi oggi stiamo rendendoci conto che bisogna tentare di rappresentare Čechov non sulla falsariga di Stanislavskij (e fu nostro compito conquistare questa dimensione), ma su un altro versante: quello più universale-simbolico, più aperto a sollecitazioni fantastiche; con il terribile pericolo di ricadere in una specie di astrazione tutto fare, di togliere “ogni significanza” alla realtà plastica di Čechov, cioè alle cose: che sono stanze, tavoli, sedie, finestre, cose e, insomma, soprattutto storia.
Perché la storia è “vista” dallo spettatore come ambiente, e come costumi e visi e capelli e occhiali e colletti e altro. Occorre ovviamente anche il resto, e cioè la storia dentro le cose e nei personaggi. Ma isolare un atto di Čechov in una “scena astratta”, in un vuoto simbolico, è togliere “realtà” plastica alla storia. È come dire che questo si svolge oggi e sempre.
Ora, il problema di Čechov è sempre quello che io chiamo delle “tre scatole cinesi”. Ci sono tre scatole: una dentro l’altra, a stretto contatto, l’ultima contiene la penultima, la penultima la prima. La prima scatola è la scatola del “Vero” (del possibile Vero che in teatro è il massimo Vero), e il racconto è un racconto umano, interessante. Non è vero, ad esempio, che il Giardino non ha una trama “divertente”. È anzi pieno di colpi di scena, pieno di avvenimenti, di trovate, di atmosfere, di caratteri che mutano. È una storia umana bellissima, è un’avventura umana emozionante. In questa prima scatola si racconta dunque la storia della famiglia di Gaiev e di Liubov, e di altri. Ed è una storia vera, che si colloca certo nella storia, certo nella grande vita, ma il suo interesse sta proprio in questo suo far vedere come vivono davvero i personaggi, e dove vivono. È un’interpretazione-visione “realistica”, simile a una ottima ricostruzione come la si potrebbe tentare in un film di atmosfera.
La seconda scatola invece è la scatola della Storia. Qui l’avventura della famiglia è vista tutta sotto l’angolatura della Storia, che non è assente nella prima scatola, ma ne costituisce il sottofondo lontano, la traccia quasi invisibile. Qui invece la Storia non è solo “costume” o “oggetto”: è lo scopo del racconto. Qui interessa di più il muoversi delle classi sociali in rapporto dialettico tra di loro. Il mutamento dei caratteri e delle cose come passaggi di proprietà. I personaggi sono certo loro stessi “gente umana”, con precisi caratteri individuali, certi vestiti, e certi visi, ma rappresentano – in primo piano – una parte della Storia che si muove: sono la borghesia possidente che sta morendo di apatia e di assenza, la nuova classe capitalistica che sale e si impadronisce, la nuova giovanissima, imprecisa rivoluzione che si annuncia, e così via. Qui stanze, oggetti, cose, vestiti, gesti, pur mantenendo il loro carattere plausibile, sono come “spostati” un poco, sono “straniati” nel discorso e nella prospettiva della Storia. Indubbiamente, la seconda scatola contiene la prima, ma appunto per questo è più grande. Le due scatole si completano.
La terza scatola è infine la scatola della Vita. La grande scatola dell’avventura umana; dell’uomo che nasce, cresce, vive, ama, non ama, vince, perde, capisce, non capisce, passa, muore. È una parabola “eterna” (per quanto di eterno possa esserci nel breve corso dell’uomo sulla terra). E qui i personaggi sono visti ancora nella verità di un racconto, ancora nella realtà di una storia “politica” che si muove, ma anche in una dimensione quasi “metafisica”, in una sorta di parabola sul destino dell’uomo. Ci sono i vecchi, ci sono le generazioni di mezzo, ci sono i più giovani, ci sono i giovanissimi, ci sono i padroni, i servi, i mezzi padroni, la tizia del circo, l’animale, il ridicolo, e via dicendo, c’è una specie di paradigma dell’età dell’uomo e degli uomini. La casa è “La casa” e le stanze sono “Le Stanze dell’uomo” e la storia diventa una grande parafrasi poetica da cui non è assente il racconto, non è assente la storia, ma è tutta contenuta nella grande avventura dell’uomo in quanto uomo, carne umana che passa. Questa ultima scatola porta la rappresentazione sul versante “simbolico e metafisico allusivo”, non so trovare la parola esatta. Si decanta di molto aneddoto, diventa molto più alta, si libra molto più in su.
Ogni scatola ha dunque la sua fisionomia e il suo pericolo. La prima il pericolo della minuzia pedante, del “gusto” della ricostruzione (molto Visconti) e del racconto visto dal “buco della serratura” e che si ferma quasi lì.
La seconda ha il pericolo dell’isolare i personaggi come emblemi di storia, cioè raggelati in una posizione di pesi o di tematica storica (Marx, critica a Sickingen, Lassalle, e via dicendo: ad esempio, lo “schillereggiare”), cioè di togliere umanità vera ai personaggi per ergerli a simbolica storica. Il vecchio studente non più “vecchio studente” perché è così, ma perché la Storia vuole che ci sia un vecchio studente, rappresentante di una parte oppressa, vecchio anzitempo perché ha sofferto forse anche il carcere, rappresentante del mondo nuovo che sale con incertezze e sussulti: è l’avvenire, c’è qualcosa di eroico e di positivo in lui, molto più che di negativo. E Liubov e Gaiev sono teneri dilapidatori, ma anche “viziosi”; sono i simboli di una classe decaduta (in una edizione cecoslovacca Liubov si faceva palpare le cosce sotto le sottane dal servo Iascia. E Duniascia – altro esempio –, nell’ultimo atto, era vistosamente incinta, così via; qui magari in ossequio al pan-erotismo attuale, senza il quale non si fa teatro moderno!). La scena è ancora quella di prima, ma già più trasposta, più segnata come ambiente forse precario, vecchio e cadente a pezzi, e altro.
La terza ha il pericolo di diventare solo “astratta”. Solo metafisica. Fuori quasi del tempo. Ambiente neutro. Un teatro coperto da un fondale di un certo colore, con alcune cose dietro. (Ritorniamo a Pitoëff, magari con i trucchi di materia di Svoboda: non cambia). I personaggi qui sono vestiti, certo, ma appena “nel tempo”: essi tentano piuttosto di diventare emblemi universali, non so attraverso quali mezzi o metodi. Ma comunque tutta la rappresentazione diventa astratta, simbolica, universale, perdendo quasi il peso terreno.
Ora, Il giardino dei ciliegi di Čechov è “tutte e tre le scatole”, una dentro l’altra. Insieme.
Perché ogni grande poeta di ogni tempo si muove, quando è veramente poeta, sui tre piani contemporaneamente; e questi tre piani possono essere scissi solo per gioco o per studio, come l’entomologo che seziona un essere vivente per studiarne alcune caratteristiche sotto vitro.
Perché l’essere vive, non è afferrabile nel suo movimento e non è riconducibile a una delle sue caratteristiche. Bisogna prenderlo tutto insieme, per saperlo. I poeti sanno, e ci danno figure eterne e contingenti, la storia dialettica (rivoluzione e reazione, mondo vecchio e mondo nuovo) e la storia dell’avventura umana, che è anch’essa tutto: piccola cosa che significa solo se stessa e il suo amore o dolore o gioia, e al tempo stesso Storia, membro irriducibile ad altro di un suo contesto sociale, e nello stesso tempo “essere umano” che porta avanti questa cosa strana, profonda, misteriosa; sì, certo, anche misteriosa, che è la vita dell’uomo, dal primo giorno a quello che sarà l’ultimo. Una rappresentazione “giusta” dovrebbe darci sulla scena le tre prospettive unite insieme, ora lasciandoci vedere meglio il moto di un cuore o di una mano, ora facendoci balenare davanti agli occhi la Storia, ora ponendoci una domanda sul destino di questa nostra umanità che nasce e deve invecchiare e morire, nonostante tutto il resto, Marx compreso. Una scena “giusta” dovrebbe essere capace di vibrare come una luce che si muove alle tre sollecitazioni…Dagli appunti di regia, pubblicati nel programma di sala e, con tagli, in Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, a cura di Sinah Kessler, Milano, Feltrinelli, 1974; ripubblicati, in seguito, nell’edizione BUR de Il giardino dei ciliegi, a cura Luigi Lunari, 1975
- L’immagine del biliardo
11 febbraio 1974
Atto terzo. Il biliardo. Continua l’immagine del biliardo, al centro, per il gioco: rumore di biglie che si toccano, che si deviano, abbattono birilli, entrano negli angoli, vengono riprese, rimesse in gioco. Il biliardo mi risulta come un’altra immagine tipica: l’armadio-mamma del primo e quarto atto.
Esso può essere: il caso, l’azzardo non totale, il senso del gioco della vita, il conflitto, l’urto, lo scambio; e, sul piano realistico-naturalistico, il “biliardo”, strumento prediletto e, in un certo senso, mania-rovina di Gaiev e della famiglia. La famiglia ha giocato, gioca ancora con “la realtà della vita”. Spera nel caso, nella felice predisposizione del gioco, nel colpo fortunato, e anche nell’abilità dell’habitué.
Non a caso, anche qui Gaiev è un “gran giocatore” di biliardo. Il biliardo è stato scelto a simbolo di altro gioco: troppo comuni le carte, avrebbero potuto anche essere i cavalli e la roulette. Ma forse è più straordinario l’essersi rovinato per il biliardo, o per il biliardo-simbolo. Le carte potrebbero assolvere assai bene anche loro a questo concetto simbolico-veristico, ma hanno una cosa in meno del biliardo: non fanno rumore. Il rumore deve essere fatto dalle parole di chi gioca. Le carte sono il caso silenzioso, unito all’abilità silenziosa. Il biliardo “suona” da solo. Nel silenzio meglio ancora: si sentono le biglie correre, urtarsi, combinarsi, muoversi, sfiorarsi per tornare poi in gioco. Si crea immediatamente una simbologia non visiva ma sonora. Il visivo è dato dall’elemento “giocatore”, che punta la stecca e dà il colpo d’avvio, poi aspetta il risultato.
Ma la posizione delle biglie non è risultato della sola abilità. È anche frutto del caso, il modo in cui esse si presentano all’altro giocatore.
Per il Giardino e per Čechov il biliardo è il miglior elemento simbologico che si potesse scegliere. Ed è stato infatti scelto, anche se nel testo è un controcanto, e anche se è tutta da definire la misura della sua presenza, se “da protagonista” o meno, se visiva o puramente sonora, oppure anche – al limite – se puramente affidata ai gesti, alle espressioni di Gaiev.
Qui nasce il primo problema. Il terzo atto è l’atto del presente, della festa, dei giochi, del caso, mentre altrove avviene qualche altra cosa. Gli elementi della festa e del gioco ci sono tutti: il biliardo (ovunque o comunque sia), il ballo con l’orchestra che suona fuori scena, passaggi di quadriglia in scena, i giochi di prestigio di Charlotte, le carte prima e le sparizioni e apparizioni poi, lo spettacolo, il travestimento, l’attore o l’attrice o clown (Charlotte vestita da uomo)…
Tutto. Il dramma dell’asta e della “perdita della proprietà”, del mutamento, del trapasso di poteri e di beni, avviene in questo clima di festa, musica, gioco, figure e rumori e suoni e applausi e danze. Ed è chiaramente ancora il “vero” plausibile, possibile ed eterno. È possibile dunque scegliere come “centro di focalizzazione” di tutto ciò il biliardo? Non è limitare a un simbolo di realtà del tutto? Sarebbe come mettere al centro l’orchestrina ebraica. O far ballare sempre tutti. O altro.
Purtuttavia, poiché questo «salotto che un arco divide dalla sala» deve avere per forza un suo centro e delle sue parti di appoggio alla recitazione, più ancora che alla situazione, possiamo ipotizzare questa soluzione: “fuori”, tutti gli elementi sonori (musica, biliardo, danza, voci, brindisi e altro); “dentro”, solo le azioni importanti. Ma ecco che avvengono alcune azioni del gioco anche in scena: il gioco delle carte, lo spettacolo, il travestimento. Dove avvengono? E prima ancora, in che cosa consisteva l’elemento plastico simbolico-realistico del salotto per i personaggi? Ovviamente nelle “cose per sedersi”: divano e sedie, oppure poltrone e sedie. Sono queste l’elemento tipico che può dare sostegno all’azione, può significare una “storia”, può dare il senso della proprietà in rovina, il metafisico anche della sedia vuota, il tempo o altro. La sedia o poltrona, certo, se sola in scena è un elemento straniante potentissimo: non significa mai solo “sedersi”. Più sedie vuote sono “angoscia”; incertezza, mistero: chi si siederà? Si siederà mai qualcuno? Cosa aspettano quelle sedie? Chi? Vuote, sono anche solitudine; occupate, possono essere la conversazione, la società raccolta, la gente. Gente che con le sedie può fare tutto: può fare all’amore, o morirci sopra.
Tornando al biliardo, potrebbe trovarsi al centro, con le sedie e le poltrone lungo il perimetro. Non è detto che si debba sempre giocare. Il gioco può aver luogo quando serve. Ma il biliardo potrebbe diventare un piccolo palcoscenico per la rappresentazione di Charlotte, o un punto di sostegno per una conversazione: Lopachin le può usare come un trono, un punto di arrivo, se nel suo delirio vi si arrampica e parla, per poi scenderne sconsolato. Sul biliardo si può anche dormire, se si vuole. Lopachin potrebbe stracciare il panno verde e pronunciare la sua battuta: «Posso pagare tutto, io»… Gaiev può giocare da solo…
E l’orchestra, invece, suona invisibile. Essa è l’atmosfera della festa che si interrompe continuamente. Ma anche i giochi negli altri rituali festivi sottolineano, in controcanto, l’avvenimento decisivo che sta per arrivare.
Qui una festa impossibile, continuamente presente e lontana, continua e interrotta, lo spettacolo, il gioco del biliardo; là il gioco cruento, anche se combattuto ancora all’arma bianca, dell’asta; il gioco, voluttuoso persino, dell’azzardo, del “gioco” capitalistico (che cos’è se non un “incontro”, un altro rituale, il “match”, quello che poi Lopachin racconta come un cronista patetico, e che è avvenuto nella sala delle aste?). A un certo momento il “giocatore” vincitore – Lopachin: la nuova classe che prende il suo posto nella storia, anche se non per molto, l’uomo più nuovo, e più giusto, il più “forte” nell’eterno rifarsi della vita umana – entra in un contatto con l’altro rituale, più stanco, della festa mancata o che si regge appena. Le parole di Lopachin («Su, musica, più forza, più ritmo, più allegria…») sono un qualcosa di concreto, come concrete sono le lacrime di Liubov che sconsolatamente piange la sua vita perduta, il suo posto perduto e la sua infanzia, adesso sì, forse, per sempre perduta, definitivamente uccisa.s. d. (aprile)
…Soluzione improvvisa. Il dubbio, non mai eliminato, ha avuto ragione: niente biliardo in scena, troppo polivalente (punto d’appoggio, palcoscenico, trono) per essere veramente essenziale. Il biliardo è “di là”, a simboleggiare la componente casuale di tutto ciò che – sempre “di là”, vicino o lontano – avviene. In scena, solo sedie, ora vuote – con tutti i significati del loro esser vuote –, ora occupate…Dagli appunti di regia, pubblicati nel programma di sala e, con tagli, in Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, a cura di Sinah Kessler, Milano, Feltrinelli, 1974; ripubblicati, in seguito, nell’edizione BUR de Il giardino dei ciliegi, a cura Luigi Lunari, 1975
- Il tempo e il ritmo del Giardino
1° marzo 1974
Il tempo reale del Giardino non corrisponde sempre al tempo teatrale. Oppure… è una di quelle indicazioni diabolicamente nascoste del vecchio Anton Pavlovič, quelle che facevano impazzire Stanislavskij. Il primo atto: si apre alle due, alla fine dell’atto siamo a «quasi le tre». Quanto dura l’atto, recitato con il suo ritmo giusto? Quaranta minuti? Troppi. Io non credo, nonostante la retorica della pausa nelle nostre interpretazioni di Čechov. Oggi però siamo alla retorica inversa. La verità è che Čechov ha un suo ritmo, interno, che è quello che è. Bisogna scoprirlo al di là della lingua, al di là delle abitudini, delle retoriche, dei nostri piaceri. Certo è un ritmo più rilevato di quello che usavamo una volta. È più scorrevole, meno sottolineato, meno “fatalistico”. Ma Čechov, per fare il “finto vaudeville”, non lo si deve recitare come una “pochade”. Non si deve aver paura del silenzio quando occorre. Il primo atto di quaranta minuti. E allora siamo lì, al tempo reale e teatrale unitario.
Il secondo atto: tempo reale e teatrale unitario. Il crepuscolo: durata trenta minuti?
Il terzo: durata anche qui reale e teatrale unitaria. Il quarto è sicuro che dovrebbe durare venti minuti o diciannove come dice Čechov. E mette apposta anche l’indicazione. «Tra venti minuti dovete essere in carrozza. Il treno parte tra quarantasei minuti».
Ricordare che Čechov scrive che Konstantin faceva durare l’ultimo atto proprio quarantacinque minuti circa e che lui gli dice in chiare lettere che dovrebbe durare diciannove. Un minuto lo lascia perché partano le carrozze! «Incredibile» direbbe Piscik. Il tempo del Giardino corrisponde dunque misteriosamente a un tempo reale. E come tale non deve essere artefatto. Il ritmo dell’ultimo atto appare abbastanza sostenuto ma lascia il suo spazio al silenzio. Bisognerebbe controllare il tempo della dizione russa (lingua) e il tempo di allora, degli attori: non poteva non essere lento, di abitudine.
Da qui, probabilmente, l’indicazione doppia “vaudeville”, per “non lacrimoso” e non “grave alla russa”, “lento alla russa”. Tutto qui. «Siate più leggeri, più fluidi, più semplici, meno fatalistici, meno drammatici, siate anche più allegri, come nella vita. Vita trasposta, ma vita. Come la mia indicazione “tra le lacrime”. Io volevo dire solo che tale era lo stato d’animo dentro, del personaggio, non che piange. È un modo di dire convenzionale». Quanti equivoci su questo modo convenzionale, povero Čechov! Certo che quando Čechov scrive che sta preparando una commedia «tutta da ridere» e questa è poi Il giardino dei ciliegi viene fatto di domandarsi cosa avesse in testa in quel momento…
[Pensando] alla fine ironia cechoviana, al suo modo indiretto di dire le cose e fare le sue critiche, forse tutto diventa più facile. Proprio perché Čechov sapeva cosa facevano i “russi”, cosa Stanislavskij voleva che lui fosse, cercava di premunirsi con queste affermazioni drastiche.
Mai dimenticare il contesto in cui si svolge il teatro cecoviano.
Ed è qui che tutto diventa ancora più straordinario.
Perché atti come quelli del Giardino sono “inammissibili” nel contesto teatrale mondiale dell’epoca.
Sono l’ultra rivoluzione formale e sostanziale…
Una rivoluzione, a mio avviso, non ancora superata. Basta svincolare Čechov dal suo involucro retorico-naturalistico e folcloristico perché egli ci appaia ancora violentemente “al di là” del già fatto e saputo e, se si parla di valore “gestuale”, anche qui Čechov è sempre avanti. Il materiale gestico e plastico “parla” di per sé. Čechov, entro certi limiti, pare un assurdo; potrebbe essere rappresentato, per “studio”, per esercizio, “mimicamente”. Come facciamo, del resto, una “lettura” di Čechov, a tavolino. Tra le due non so quale possa essere immediatamente la più efficace.
Certo, la lettura singola, del regista, in questo caso è la più infelice. Pensiamo un attimo al valore gestuale e visivo-plastico dell’apertura del quarto atto: la scena, il vassoio con i calici di champagne, l’unica bottiglia falsa, le calosce di Trofimov, l’arrivo dalla quinta di un paio di calosce vecchie e sfondate che cadono con un tonfo sul palco e restano, con una voce in quinta che dice: «Tenetevele le vostre schifezze!» o qualcosa del genere. E Trofimov che le prende, le guarda un attimo e le ributta via: «Non sono le mie!».10 marzo
Il tempo. Problemi del tempo. In questo vaudeville-tragedia-commedia-farsa-dramma, in questo tutto che sempre più mi appare più grande, più perfetto, più denso nella sua chiarità, direi nella sua innocenza. Sto ascoltando Mozart: il quintetto K 516, e penso alla chiarità di Mozart… così vera e così profonda…
Il concetto del tempo è fondamentale.
Annoto oggi – per la prima volta, mi pare – un fatto evidente ma al quale non avevo forse riflettuto abbastanza: Liubov è stata via cinque anni. Quando ritorna, Lopachin si domanda: «Mi conoscerà?». E poi ancora: «Chissà come sarà adesso?». Poi Duniascia non viene riconosciuta da Iascia. Poi Trofimov non viene riconosciuto da Liubov, e continuamente durante tutto il primo atto i personaggi guardano e parlano di come «le stanze sono rimaste le stesse, il giardino lo stesso», e di come, nello stesso tempo, le persone sono cambiate tutte o quasi. Anche Firs: «Come è invecchiato!» Liubov dice: «Grazie a Dio, sei ancora vivo!».
È chiaro che il primo fatto è questo: le cose non cambiano, restano immobili, giardini, oggetti, muri e stanze e mobili… (penso adesso all’inizio, stupendo, di Comisso in Gioventù che muore, con quella donna che nella neve, nel sole e nell’azzurro sente per la prima volta che quelle cose resteranno così per sempre, e lei no, lei diventerà vecchia e morirà: l’estasi della natura immobile, mentre gli uomini passano).
E poi: gli uomini passano in fretta.
Bastano cinque anni per cambiarli tutti. In questo senso i cinque anni all’estero sono una vita. Sembrano più lunghi, soggettivamente e oggettivamente. I cinque anni non sono solo cinque anni, sono il tempo che passa e modifica.
Di qui il sentimento dell’incertezza, del troppo mutato o del tutto rimasto come prima. Questo atto così sospeso, così incerto, questo passo all’indietro nel passato mentre tutti sono andati avanti nel presente e si proiettano nel futuro… questo ritorno all’infanzia, nel sonno dell’alba, nella stanchezza dentro e fuori, in questo sfinimento dei nervi troppo tesi per troppa vita e caffè… è davvero «incredibile», come dice Piscik. Incredibile, come l’esistenza sulla terra, incredibile, come l’esserci e l’andare… Liubov dice a tutti che sono invecchiati. Mai lo dice di se stessa. Liubov non ha conoscenza del “suo” tempo. Ed è giusto che sia così.
Liubov è l’anima che non cambia, quella che resta sempre così, che forse niente tocca. Ma anche se si resta nel cerchio della “prima scatola”, non è difficile conoscere il tempo degli altri; difficile è riconoscere il proprio. Gli altri sono “diversi” da noi. Noi ci ritroviamo “troppo vecchi” o “troppo giovani”; quella realtà temporale che è la nostra, ci sfugge. Forse “deve” sfuggirci, perché altrimenti non ci sopporteremmo. Troppo lancinante è questo cammino ineluttabile nel tempo, questa impossibilità di “capire” il movimento dell’esistenza.
Quanto a Liubov, poi, in particolare, lei forse non vuole nemmeno pensarci, al tempo. Lei non si pone il problema, e anche fisicamente – io credo – Liubov è una di quelle donne incredibili che sembrano ferme, con gli occhi spalancati, sulla voragine degli anni, immutabili come bambole di porcellana di cui il tempo si limita a scalfirne appena appena lo smalto… Liubov – non l’anima: lei donna, come donna – non vede che gli altri. Di sé è cosciente solo in una “fuga verso il passato”. Quella nostalgia dell’infanzia perduta e anche di un’innocenza perduta, che fanno di lei, ancora una volta, come sempre, la verità umana e il simbolo delle nostre misteriose proiezioni nel mondo ancestrale, fino a quell’utero caldo e silenzioso, materno, che ci ha protetti un tempo e di cui, come esseri vivi, sentiremo sempre la nostalgia profonda.Dagli appunti di regia, pubblicati nel programma di sala e, con tagli, in Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, a cura di Sinah Kessler, Milano, Feltrinelli, 1974; ripubblicati, in seguito, nell’edizione BUR de Il giardino dei ciliegi, a cura Luigi Lunari, 1975
- Il secondo atto: un intermezzo all’aperto
16 marzo 1974
Il secondo atto del Giardino si svolge all’aperto. È l’unico atto che si svolge all’aperto. Ha l’aspetto di un “intermezzo”, di una cantata a più voci nel corpo dei quattro atti della storia del giardino. In tutti gli altri atti “succede” qualcosa: o, anzi, succede molto. Nel secondo c’è come una stasi dell’azione reale, c’è una specie di immobilità ineluttabile delle figure che “stanno lì”, siedono dopo la passeggiata, “aspettano il tramonto”, vedono la natura, e parlano, discorrono.
E la vita ovviamente va, come i barchetti al filo dell’acqua di Montale; anche se i personaggi restano fisicamente immobili, l’azione continua all’interno, anche se l’intrigo è come sospeso, in un arresto attonito, in un ripiegamento su di sé, in una meditazione lirica, dove alcune posizioni gestuali sono sufficienti e vengono appena variate. (L’esempio potrebbe essere di colui che fuma una sigaretta, ripete i gesti soliti di chi fuma, ma fra i tanti che fumano ognuno ripete quei gesti a modo suo, con un proprio tempo, una propria attenzione o disattenzione, una propria voluttà o meno, indifferenza o altro. Ma il gesto del fumare è uno solo e uguale, nel fondo, per tutti).
Qui la natura è diventata il palco che ha assunto altre inclinazioni, e il grande tappeto grigio lucente giardino diventa cielo nel fondo, tirato su e srotolato dalla camera dei bambini, dal divano, verso l’alto. Attraverso una grande lacerazione antica del tappeto-cielo-giardino, il plastico della città che cresce e il trenino magico che passa all’orizzonte. Il trenino poi ripasserà sul davanti, davanti ai personaggi che lo fisseranno e lo sentiranno fischiare nella sua reale irrealtà di vita vera e gioco infantile e gioco di palcoscenico. Il secondo tempo sarà animato da questi passaggi…
E qui andrà eliminata tutta la simbologia segnata da Čechov: la cappella cadente, le pietre tombali, i simboli di un mondo che sta in bilico, di cose morte, di una verità che vacilla, del passato sepolto, del domani che cresce (la città e i pali del telegrafo), della civiltà industriale che viene avanti, sempre più avanti…
Ho sempre pensato che questa simbologia fosse un retaggio di gusto incerto, una pericolosa tendenza al simbolismo che Čechov quasi sempre evita con una straordinaria abilità. (Anche qui, all’atto pratico della rappresentazione, Čechov sembra fare macchina indietro sulle proprie stesse didascalie: lettera a Nemirovič-Dančenko del 23 ottobre 1903: «Nel second’atto non c’è nessun cimitero»!). È una simbologia che non può arrivare al pubblico con la forza diretta con la quale arrivano la simbologia della camera dei bambini, del salone della festa, dell’ammucchiarsi dei mobili dell’ultimo atto, delle valigie della partenza nella scena vuota con poca roba ammucchiata. Perché tutte queste sono le simbologie che nascono da una realtà plausibile non composta, mentre quella del secondo atto può essere plausibile ma è troppo “ben composta” ad arte per non apparire artificiosa. Non c’è bisogno di questa simbologia totale: basta la simbologia diretta della città che cresce e del treno che passa: di quel treno che Čechov non voleva che passasse; o, meglio, di cui poco gli importava. (Altra lettera: a Stanislavskij, 23 novembre 1903: «Se il treno si mostrasse senza rumore, senza alcun suono, allora fatelo passare»).
A Čechov bastano i silenziosi pali del telegrafo e le ciminiere della città nella nebbia del fondo per dire che un mondo nuovo sta sorgendo lì presso; gli bastano i personaggi per dire che un mondo vecchio muore. Ma se noi faremo correre quel trenino non sarà per memoria di Stanislavskij, ma per immettere sempre il doppio tema dell’infanzia perduta e del gioco in una doppia prospettiva: il treno lontano che passa nel fondo può essere, è un qualcosa di vero; davanti, è un giocattolo che fugge, fugge traballando sulle sue piccole finte rotaie. È qui, nel second’atto, che per la prima volta si verifica quel “rumore” famoso della corda spezzata; problema sul quale tutti i registi del mondo si sono spezzati le corna. Non credo che la soluzione demistificatoria di qualche regista attuale (un piccolo suono di gong per cambiare “atmosfera”) sia la soluzione giusta.
Meglio allora, coraggiosamente, nulla. E perché no? Perché questo suono-simbolo non potrebbe essere qualcosa che i personaggi nel crepuscolo sentono: sentono “loro”, ma non noi, pubblico che guarda?
Lo so che questo è forse un semplificare o un girare attorno al problema (o meglio, così potrebbe forse apparire), ma probabilmente quel suono proprio non si deve sentire! Deve restare indeterminato, descritto da ciò che dicono gli attori-personaggi. Non è una soluzione di comodo. Solo che, ecco: il treno che passa improvvisamente si ferma, e forse deraglia “in quel momento”, e le ruote del giocattolo-mostro girano a vuoto nell’aria con un rumore di sfere e di molle che si scaricano freneticamente. Poi qualcuno rimette tutto al suo posto, la macchina di nuovo carica, il trenino riprende ad andare e sparisce traballando in quinta per poi riapparire sul fondo come prima.
Ogni personaggio-attore avrà un sussulto, e tutti guarderanno e tenderanno le orecchie in varie direzioni, anche opposte tra loro. Uno verrà alla ribalta, scenderà magari verso il pubblico cercando il “suono” nella platea, interrogando la platea con lo sguardo e con un piccolo gesto della mano. Ma nessuno riuscirà a individuare il “punto” da cui il suono “interiore” è partito. Quel suono è un brivido della storia, al quale i personaggi danno la più banale delle spiegazioni possibili. Unica Liubov, che dice: «Non so perché, ma non mi piace». Il brivido della storia non lo si simboleggia né lo si oggettivizza con un suono. Neanche con il marchingegno di Stanislavskij e Dančenko.
Oggi, fino a prova contraria, io credo che quel famoso suono sia un’illusione letteraria, un sedimento di scrittura per evocare un fatto sonoro, e che ha l’aspetto di una teatralità oggettiva. E questa ce l’ha per certo: sembra fatto apposta per dare uno scatto ritmico al finale dell’ultimo atto, ad esempio. Ma, appunto, lì si demistifica come tale: è cioè un espediente in più. Io credo che nessuno possa rifiutare l’idea che lo stesso suono inteso al secondo atto, ripetuto nell’ultimo atto a scena vuota, con Firs immobile, nella sua reale-apparente morte, sia non necessario, e che sia anzi di troppo.
Tanto più che, insieme a quel suono, ci sono anche i famosi colpi di scure sui ciliegi. Così, io penso che questo suono non lo realizzerò con un “suono”, ma con un “suono silenzioso” più sonoro di un colpo di lama o di fucile. Il punto è qui.Dagli appunti di regia, pubblicati nel programma di sala e, con tagli, in Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, a cura di Sinah Kessler, Milano, Feltrinelli, 1974; ripubblicati, in seguito, nell’edizione BUR de Il giardino dei ciliegi, a cura Luigi Lunari, 1975
- Il giardino: un palpitante cielo teatrale
6 febbraio 1974
Il giardino vero e proprio è il punto di coagulazione della storia, è il suo protagonista; ed è nel giardino che si trova, proprio per questo, l’enorme difficoltà interpretativa. Non farlo vedere, darlo per supposto, è un errore. Farlo vedere e sentire, è un altro errore. Il giardino deve esistere, deve essere qualcosa che si vede e si sente quasi (arrivo a pensare persino all’odore, o solo all’odore, per gioco!), ma non può non essere “un tuffo”. Perché il tutto si concentra. Il giardino per me è in “primo piano”.
È attraverso il giardino che si vede la storia. È uno schermo attraverso il quale, non deformato, si vede tutto il resto. Nel modo più volgare è un sipario di velo, a giardino, che funge da quarta parete, e si vede e non si vede. Ma, ripeto, questo è un modo volgare per chiarire un punto critico. Ma c’è anche di più. Non basta un piano davanti, occorre qualcosa di più.
È questo “qualcosa di più” che non riesco per ora ad afferrare. Che mi sfugge tra le dita. Anche perché le difficoltà, gli enigmi tecnici mi sono davanti e mi paralizzano quasi del tutto…21 marzo
Il giardino si è precisato in immagine. Quel giardino che ci deve essere e non essere, che deve stare davanti e che a gennaio era una sensazione, ora sta diventando qualcosa. Luciano ha proposto una “cosa in alto” che investe gli spettatori, ma “da sopra”. Su questa idea, non ancora immagine, abbiamo lavorato e siamo giunti alla decisione di tentare il “giardino” come una “cupola” lieve, di stoffa, non velo ma altro, che può palpitare, che è trasparente, che sale sopra la platea, in luce e movimento e colore e che si proietta nella scena come un soffitto ideale che prolunga quello invisibile di una casa. L’immagine non è ancora chiara, solo la prova reale ci potrà dare la misura del suo valore evocativo-plastico-poetico.
Io credo che questa apparenza non simbolica, poiché si tratta di qualcosa di reale, questa luce-atmosfera che varia negli atti, questo palpitare di un cielo teatrale, con foglie di carta sottile che frusciano con un suono “trasposto” e altri effetti imprevedibili, possono dare concretamente questo incredibile giardino di Čechov meglio di ogni altro fatto teatrale o di una sua assenza per finto amore di “castità” o “nudità”. Ma non solo, la scena stessa è arrivata a definire quello spazio bianco che Čechov ipotizzava nella sua lettera del 5 ottobre da Jalta. In questa lettera c’è una incredibile concentrazione di “tempo”, egli parla di un giardino estivo bianco, tutto bianco, anzi totalmente bianco, e di signore vestite di bianco. Dopo un attimo aggiunge: «Fuori nevica». Straordinaria questa doppia immagine, estate-inverno, collegata sul bianco totale. Questo eterno bianco di giardino sotto i fiori bianchi della primavera e sotto la neve dell’inverno. Così mi appare certo che Il giardino dei ciliegi è nato per Čechov in un lancinante bagliore di bianco, è un bianco “senza stagione”.Dagli appunti di regia, pubblicati nel programma di sala e, con tagli, in Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, a cura di Sinah Kessler, Milano, Feltrinelli, 1974; ripubblicati, in seguito, nell’edizione BUR de Il giardino dei ciliegi, a cura Luigi Lunari, 1975
- Il Giardino della maturità
Se un interlocutore mi chiedesse perché ho scelto Il giardino dei ciliegi risponderei semplicemente: perché è un capolavoro. È uno dei grandi punti di riferimento della storia umana nella misura in cui lo sono i classici. Alla mia prima edizione, fui molto infelice. Ebbi la sensazione d’aver appena sfiorato l’anima del testo. Quella sera, mi ricordo, dopo la recita scappai in cortile, nevicava. Fuggii via come un ladro.
Riportato da Ettore Mo, Intorno a Strehler per imparare Čechov, “Il Corriere della Sera”, 13 marzo 1974
Anche allora [nel 1955] il giardino era stato un grosso problema. L’avevo risolto con alcuni tronchi che si vedevano attraverso la finestra, ma il giardino, nella sua ampiezza, nella continua presenza, non appariva. Allora si era appena usciti dal periodo dei falsi ambienti e si aveva fame di realtà, fame del tavolo, della seggiola, fame di cose concrete, di cose che si toccano. Non era per un vezzo, o per amore dell’estetismo, che Luchino Visconti voleva in scena l’orologio vero, il mobile autentico, il vestito tagliato da quel sarto. Il realismo, la conquista della realtà, da sentire sotto le dita, era una assoluta esigenza.
[…] Alla mia età, che è l’età della maturità piena, se vuoi con l’occhio puntato verso la china discendente, alcuni temi, che nella giovinezza si sfiorano appena, cominciano a diventare ruggenti, acquistano colore e rilievo. Senza, con questo, che perda vivezza la visione storicistica della realtà.Riportato da Giorgio Manzini, Strehler nella scatola di Čechov, “Paese Sera”, 8 maggio 1974
Sono al Teatro Argentina, per la prima volta a Roma con un “mio” Čechov. In queste ultime ore, nel corso di queste ultimissime prove, sempre poche, sempre febbrili, più di sempre insufficienti, ecco la sensazione – dapprima – della completa “diversità” tra questo Giardino e quello allestito ormai tanti anni fa, e l’altra sensazione – immediatamente dopo – della possibile “diversità” tra questo Giardino e quello che – chissà? – un giorno mi capiterebbe di voler fare. Teatro mai eguale a ieri, mai eguale a domani, come l’onda del fiume cantata da Brecht (la vedova Begbick di Un uomo è un uomo), che non ha mai la stessa acqua.
Ieri, il problema era quello della ricerca realistica: la preoccupazione che tutto – psicologie, rapporti sociali, vicende storiche – rispondesse a un criterio di Verità, anche se in senso più lukácsiano che banalmente naturalistico. Oggi, che non si trattava più di venire dopo Stanislavskij, ma dopo Visconti e Krejča e magari dopo lo stesso Strehler, oggi il problema mi è sembrato piuttosto quello di ricercare, per il Giardino, una dimensione non già “astratta”, ma più dilatata in senso universale, meno legata alla scena europea anni ’50, meno portata a scorgere in quel giardino soltanto alberi, o poco più che altro. Si trattava, insomma, di interpretare Čechov – un autore semplicemente immenso – nella sua dimensione più autentica: che non dimenticasse le conquiste realistiche, ma che al contempo non si limitasse al coté socioeconomico, quasi Čechov fosse Gorkij…
Del resto, in questo Giardino senza giardini in scena, senza ciliegi né “veri” né “finti”, ma con solo qualche foglia sopra di un velo enorme, un velo che è sipario e aquilone e cupola e gabbiano e vento che muove tutto, lieve, trasparente, impalpabile, aereo, in questo Giardino sono proprio questi i ciliegi, mai in scena eppure sempre in scena, in un palpitare di cielo teatrale che è un po’ una sintesi spaziotemporale della vicenda poetica immaginata da Čechov…
È diverso, il nostro “spazio” – di Damiani e mio – dalle indicazioni dettate da Čechov (al second’atto, ad esempio: quelle lapidi tombali, la cappella distrutta, e i pioppi e i pali del telegrafo…), ma anche da quel palcoscenico completamente nudo altre volte vagheggiato, un palcoscenico spoglio d’ogni riferimento, luogo d’inesistenti Utopie. È un giardino, il nostro, che vuol essere il simbolo stesso dell’esistere: luogo sì dell’infanzia, dell’innocenza, della felicità, ma anche luogo della costrizione, talvolta, luogo abitato dai servi della gleba, ancestrale ricordo di piantagioni di schiavi di ieri e di oggi. In questo giardino ho voluto ricreare un’atmosfera di leggerezza fiabesca (ma non astratta: le fiabe quasi mai lo sono), da risolvere in una cifra stilistica che fosse immediatamente visibile: donde il bisogno assoluto di semplificare, di purificare tutto, per raggiungere quello “spazio bianco” di cui dice Čechov nella sua lettera del 5 ottobre 1903 da Jalta.
Provo ancora questo Giardino (eppure siamo alla duecentocinquantesima replica) e ho netta la sensazione di non aver ancora finito di indagarlo a fondo, di “capirlo” nella sua sublime interezza. Questo nostro lavoro, da oggi e domani conoscerà il responso del pubblico romano, mi sembra soltanto (è poco? è moltissimo?) una possibile indicazione di metodo. È così per tutte le grandi matrici drammaturgiche, aperte sempre a mille interpretazioni. Perché il Giardino, forse, è la cosa più grande che il meglio della società borghese ci lascia, sul teatro, in una consapevolezza di sé che altri non sanno raggiungere.
Fuori dal teatro, in questo tardo pomeriggio di gennaio, le sirene spiegate della polizia…Le ultime prove, e non ho mai finito, “Momento-sera”, 23 gennaio 1976
- Perché ho scelto Monica Guerritore
Perché l’ho scelta? Perché la ragazza somiglia in modo impressionante alla Ingrid Bergman giovane. Quella di Per chi suona la campana, per intenderci. Ha un faccino pulito, fresco, una notevole interiorità e maturità. Sembra quasi che Čechov, nel descrivere il personaggio di Ania, si sia ispirato a lei.
Riportato da Giuseppe Bonazzoli, Com’è difficile trovarne una ingenua!, “Annabella”, 16 marzo 1974
- Cercheremo, come sempre, di fare, come meglio sappiamo, il nostro mestiere
Cari amici, la stagione è già finita. E, per merito vostro, in maniera trionfale. Ma il nostro è solo un “arrivederci”, perché l’anno prossimo ci ritroveremo ancora tutti insieme, ridaremo vita a questo nostro Giardino con amore, dedizione, e alto senso professionale. So tutto di queste repliche, dei piccoli errori e difetti, e dei grandi pregi. Cercheremo di eliminare i primi e di esaltare i secondi. Cercheremo, come sempre, di fare come meglio sappiamo, il nostro mestiere, che è quello di dire agli altri parole di grandi poeti che ci aiutino tutti a vivere. Vi abbraccio tutti affettuosamente
Lettera dattiloscritta senza data [15 giugno 1974] – Archivio Piccolo Teatro di Milano
- Valentina, io ho fatto il Giardino non per me, ma per te
Valentina adorata!
Ed eccoci arrivati alla fine del Giardino. Il nostro lavoro finisce qui. Tristemente, come finiscono tutti i lavori di teatro, ma forse di più, questa volta. C’è un male dentro di me così profondo, così scuro da non riuscire a definirlo. E in te, certo, c’è anche di più.
L’unica cosa che può salvare da questo è la certezza che il teatro va avanti e noi con lui. Credimi, non c’è altro: solo il pensare che anche questo Giardino è solo un momento di una storia di palcoscenico che ha avuto altre storie prima e avrà altre storie dopo. Tu, invece, assegni altri valori, lo vuoi far diventare “la fine di tutto”, e questo la fine di ogni nostro futuro, la fine di ogni altro lavoro di teatro, insieme, tu e io. Ma così non è, Valentina. Vorrei, non so in quale modo, potertene dare la certezza anche se penso che deve bastare ciò che continuo a dirti da sempre. Le mie promesse “nel teatro” valgono, non le ho mai smentite, e tu dovresti saperlo, per prima.
Sul resto non si può nemmeno incominciare a parlare, perché tutto è così crudele, così confuso, così fondamentalmente ingiusto da lasciarmi sbalordito… Meglio il silenzio, un silenzio grave in cui io non mi ritrovo quasi. Non è ancora venuto il momento, credo, per poter parlare e capire fino in fondo. Ma qualcosa, sì, debbo scriverti, perché lo penso, perché lo sento: non credere che io non sappia “cosa” ti è costato questo Giardino.
La maggior parte di questo sapore amaro che ho sulle labbra nasce dal sentimento preciso di averti fatto del male non volendolo. Io ho fatto il Giardino non per me, ma per te, perché ero convinto che questo spettacolo, pur nelle condizioni terribili in cui è nato, pur nella lacerazione inevitabile, sarebbe stato come la sublimazione di un nostro dolore, mio come tuo o più tuo che mio, sarebbe stato una specie di lancinante raggio di luce nel tuo male, sarebbe stata la possibilità di darti la parte migliore di me, a te e a te sola come a nessuno! Mi sono accorto invece, da subito, che così non poteva essere: il prezzo ti era troppo alto. Ho continuato a provare cercando di dare, dare, dare al tuo personaggio un amore, una tenerezza, una pienezza di sentimenti che forse non ha o non merita. Ho costruito, assai prima di uno spettacolo, assai prima di un testo, una figura umana che in parte ti corrisponde, in parte ci corrisponde, in parte no, perché è più grande probabilmente di noi, una figura umana che tu, alle prime prove, hai violentemente rappresentato con una umanità, una coerenza di sentimenti, una pienezza di arte da sbalordire. E qui, ho di nuovo creduto di avere scelto giusto. Liuba era qualcosa che dovevi fare, e fare adesso, subito. Si doveva mettere tra noi, per legarci, questa misura di poesia inalterabile, decantata, pura e poi… Ci sono state ore in cui ti ho seguita e amata con un tale abbandono, con una tale ammirazione quale mai ho provato nella mia vita. Ed ecco che qualcosa improvvisamente si è spezzato in te e tra noi, al massimo della parabola ascendente, mentre tu stavi per fare forse la cosa più bella e compiuta che io ho visto a teatro, ecco che ti sei fermata e hai cominciato a scendere. Non ti ho ritrovata più intera. Ti ho ritrovata qua e là in certi toni, in certi momenti. Non in una continuità incredibile, in una violenza di amore e poesia fatta di dolore, di infanzia, di incredulità, di abbandono, di incoerenza anche. Quello che resta è tanto, Valentina, credimi, è qualcosa di prezioso, di grande. Ma non grande come era, non grande come puoi essere, non grande come io ero riuscito a costruirti. Questo il mio sordo rimpianto, questo il mio rimprovero. E mi domando cosa c’è stato, dopo quelle lacerazioni positive, che ci ha nuovamente divisi. Sì, divisi perché in quei momenti eravamo insieme, come forse non lo siamo stati mai, per lo meno in questi ultimi anni. Qualcosa che mi è sfuggito. Qualcosa di cui sono responsabile io. Ma solo io, Valentina? Solo mia è la colpa? Vedi, se non fosse successo il miracolo di tanti giorni e ore, io oggi non starei qui a ferirmi nella memoria e nella ricerca di un perché… Ma quel miracolo era successo. Cosa l’ha fatto diventare un’altra cosa?
Liuba era e può essere, se tu questa sera spezzi di nuovo il tuo involucro di lacrime e di pena privata per proiettarla nella tua arte, una straordinaria creazione d’amore di due esseri che saranno sempre una cosa ineguagliabile l’uno per l’altro, fino alla fine. Liuba è il nostro bene di ieri e di oggi, Liuba è la prova viva di ciò che vali umanamente e di ciò che ci possiamo dare sempre. Credimi, amore mio caro, unico, è così. Ma occorre che succeda qualcosa, qualcosa che non so indicarti perché non lo conosco, non riesco a finirlo… Allora Liuba Andreievna ritornerà a essere una grande figura d’amore ricca di altro amore, il nostro, oltre quello di cui l’ha riempita l’autore, ritornerà a essere qualche altra cosa dal teatro: brandello di vita e di anima, fuoco incandescente e perenne, suono incontrollabile nella sua vibrazione… Non solo teatro, no, Valentina, assai di più o meno, non so. Altra cosa. Quella che mi aveva, ci aveva travolti per settimane.
Si tratta di un problema d’arte ma, prima ancora, di un problema umano.
L’altra sera io sono fuggito per tanti motivi, anche per questo. Ma non perché non recitavi bene, non perché non sei giusta. Cerca di capire: qui si tratta di altro. Come attrice la tua Liuba è bellissima, non ci sono dubbi, devi esserne sicura. Come essere umano che può tanto, Liuba è al di sotto del tuo amore. Ma non lo fu per molto tempo, magari con squilibri e pause. Questo il punto fondamentale. Come riuscire a comunicarti quello che provo e sento: l’ammirazione che ho per te e l’accusa che ti faccio sordamente di non essere ancora di più perché puoi essere mille volte di più? Ma ora, Valentina, è il momento di non abbandonarsi troppo a tutto ciò. È l’ora di fare quello che si può per realizzare te stessa.
Era questo però che volevo dirti ai margini del nostro Giardino? Certo, no. Forse, ecco: non mi perdonerò mai di averti fatto soffrire tanto. Oggi sono quasi sicuro che non dovevo fare questo Giardino. Né per me né per te. Sono sicuro che tu avevi ragione. Che non bisognava sottoporti a questo dolore quotidiano, quotidianamente rinnovato, in quel palcoscenico, tra quei muri, in quel “luogo”… Avevi ragione e io sono stato involontariamente mostruoso e crudele. Ma non volevo. Mi giustifico così. Non avevo nessun bisogno di fare il Giardino, io!
Avrei dovuto non farlo per salvare la mia salute ormai tanto compromessa. E facendolo ho distrutto ancora altro di te. Posso dunque darmi pace e ragione? Anche questo sta al fondo del mio lavoro, in queste ore in cui aspetto ormai impotente che si realizzi una parte sola e piccola di ciò che volevo e sapevo. Ti prego solo di perdonarmi perché ciò che è avvenuto è avvenuto in purità di cuore e non per incoscienza. Per errore, niente altro.
Solo ciò che ti ho detto, quel miracolo, poteva assolvermi e dare un senso a questo enorme tuo male al quale fa riscontro un altro mio enorme male. Così chiudo queste mie righe disperate, più disperate di quello che paiono. Sono qui, ormai senza forze, né parole, stanco stanco stanco…
Ti bacio teneramente, il tuo
GiorgioLettera dattiloscritta senza data (probabilmente 1974) indirizzata a Valentina Cortese, pubblicata in Giorgio Strehler, Lettere sul teatro, a cura di Stella Casiraghi, Milano, Archinto, 2000
Video
Bozzetti
Fotografie
In tournée
Documenti
- Luciano Damiani. La prima relazione riguardante la scenografia del Giardino dei ciliegi
La scena è costituita dai seguenti elementi: un grande velo in seta che passa dal palcoscenico in sala tenuto sollevato da due stangoni. Il velo contiene al centro delle foglie di ciliegio. Il boccascena è intonacato. L’avanscena è costituito da armature per cantiere edile e il piano di palcoscenico è fatto con tavole da cantiere con le possibilità di cambiare la pendenza e la forma.
Al di sopra della pedana c’è un tappeto in rayon e cotone che deborda in avanscena ricadendo sul piano di platea. Lo stesso tappeto, in parte rotto, sale verticale a guisa di fondale per il secondo atto e serve da tendaggio nel terzo atto. Sul tappeto sono dipinte delle “ombre” degli alberi del giardino.
Sulla pedana si alternano i mobili:
I atto – armadio, divani, giochi e mobiletti dei bambini;
II atto – trenino, plastico città;
III atto – biliardo, sedie.
Dietro la pedana, a guisa di fondale per la copertura e cancellazione della struttura interna del palcoscenico, ci saranno delle strisce di garza o tarlantana appese a degli stangoni e fissate a terra.
Per il II atto, all’interno delle garze nella parte centrale sono inseriti un plastico della città in lontananza e un plastico della linea ferroviaria con la massicciata e il trenino.
Ci sono dei lampadari con candele per il I e il III atto e delle piccole lampade per la festa del III atto appese in palcoscenico e in platea.Il velo
Necessità di tre tiri in sala per sorreggerlo, passa dal palcoscenico in sala attraverso il boccascena. Occorre effettuare un sopralluogo nelle intercapedini per vedere se è possibile applicare tre carrucole all’esterno o interno del soffitto per appendere lo stangone che regge il velo.
Il peso dello stangone più il velo si aggira sui 10/15 Kg, a ogni tiro diamo una tolleranza di 20 Kg per la sicurezza. Sempre in sala, dai fori di areazione o decorazione del soffitto dovranno calare dei fili o delle carrucole alle quali sono appese delle piccole lampade, circa una decina. L’alzamento e l’abbassamento che verrà effettuato nell’intervallo fra il II e III atto potrà effettuarsi dalle balconate di destra o sinistra e lo stesso potrebbe avvenire per lo stangone che regge il velo per il finale.
Lo stangone del velo si trova a circa m 10,5 dal boccascena, il secondo stangone è in palcoscenico. Il velo cambia posizione secondo gli atti con la sola manovra, almeno per ora, del tiro di palcoscenico. Il velo è in seta, cucito a strisce di cm 90 per la lunghezza.
Prima della confezione la seta dovrà essere ignifugata, avendo nel III atto, anche se relativamente distanti dal velo, dei lampadari con candele accese.
La ignifugazione può essere affidata alla ditta Sambrotta. Il velo sarà cucito dalla sartoria del teatro e invieremo il campione della cucitura. Una volta confezionato in base ai disegni esecutivi e al modello che verrà fornito, a velo montato, la Sibilla [Ulzamer, assistente alle scene e ai costumi] potrà curare la rifinitura del drappeggio.Il boccascena e l’avanscena
Il boccascena è spoglio, occorre smontare, se c’è il sipario, l’arlecchino e i panni russi. Il riquadro è ridotto in altezza con l’applicazione nella parte superiore di un abbassamento in legno a imitazione intonaco esistente. La fossa dell’orchestra è aperta, le pareti frontali e lo spessore dell’avanscena sono rivestiti, come da disegno, con telai in compensato più tela e intonaco a imitazione di quello esistente del boccascena.
Il boccascena nella parte bassa ha tracce di umidità, l’intonaco sgretolato da scuro sfuma sul chiaro salendo verso l’alto. Nell’avanscena sull’orchestra c’è una costruzione tipo impalcatura per cantiere edilizio. Il materiale che compone questa impalcatura e il materiale per il piano di palcoscenico sono tavole grigie come quelle dei cantieri o palanche, paletti in legno o triestine, traversine di legno – tutto materiale usato, impolverato, vissuto, intriso di calce. Per ottenere degli effetti di incrostazione in rilievo, muffe, ecc. occorre del silicato liquido pennellato sul legno e bruciato con lo chalumeau.
A destra e a sinistra dell’avanscena sul piano di palcoscenico e a terra sul piano di platea vi sono cumuli di detriti di costruzione, resti di un muro demolito: mattoni, terra, ecc.
Nella costruzione dell’avanscena vi sono due tavole in scivolo, collegate al centro e praticabili.La pedana
Il piano di palcoscenico è costituito da una serie di tavole da cantiere, in parte vere e in parte imitate; la parte vera l’avanscena fisso, mentre la parte interna è in tavole imitate. Il piano dell’avanscena fisso termina a m 1,20 all’interno del filo del boccascena e su questa linea è fissato a una grossa cerniera un telaio di ferro. Questo telaio in ferro ha sulla destra una diagonale che dista nella parte alta m 1,6 dalla fine del telaio stesso.
Sulla linea della diagonale vi è una cerniera e la pedana viene così divisa in due settori B e C.
Questa intelaiatura in ferro dovrebbe essere il più leggera possibile e dovrà diventare rigida una volta che verranno fissati i compensati o panforti che costituiscono la base della pedana. Questi compensati devono essere il più grande possibile per evitare giunture e sono imbullonati all’intelaiatura stessa. I compensati hanno riportate delle tavolette di 10/12 mm lavorate a imitazione tavole cantiere.
Questa pedana ha una pendenza che si somma al declivio del palcoscenico del teatro e, appunto per evitare un eccessivo declivio, si dovrà contenere l’intelaiatura più il tavolato in misure estremamente ridotte – fra gli 8 cm nella parte avanti e i 13 cm nella parte dietro.
La cerniera parallela al boccascena è leggermente sollevata da terra per la funzionalità.
La pedana ha tre diverse posizioni e varia in particolare la posizione del settore C (vedi disegno). L’alzamento della pedana avviene mediante leve manuali o meccaniche, tipo crick delle automobili. Una volta sollevata, si faranno scorrere sotto i sostegni delle cavalle, in corrispondenza di apposite guide previste nell’intelaiatura in ferro.
I movimenti sono per il settore C riguardante la diagonale di destra: una alzata di cm 35 per il I e IV atto. Per il III atto l’alzata è di 50 cm.
Per il II atto la pedana ha un grosso movimento in ambedue i settori. Il settore C si alza a m 1,85 – non è praticabile e quindi non necessita di particolari sostegni, l’altra parte invece è praticabile.
L’inclinazione è di m 1,20.
Queste misure riguardano un progetto di massima, seguiteranno le misure definitive dopo un colloquio con i costruttori.
Lateralmente alla pedana centrale vi sono due pedane di raccordo con, a destra e a sinistra, una appendice in quinta (vedi piante), e la superficie è in tavole come la pedana centrale.Il tappeto
Sulla pedana c’è un tappeto in rayon e cotone a fondo rosso. Il tappeto è già stato commissionato in data 05-03-1974 con lettera di cui vi abbiamo inviato copia e vi giungerà il preventivo. Il tappeto sarà decolorato dalla ditta Sambrotta e la sartoria cucirà i teli insieme, come da disegno.
La pittura sul tappeto dovrà essere eseguita con aniline ad alcool, possibilmente con un fissativo affinché il colore non spanda – dato che sarà necessario pettinare il tappeto inumidendolo. Occorre fare delle prove in tal senso. Il tappeto è costituito da due elementi uniti in un angolo a destra.
Il tappeto di fondo nel I atto è arrotolato e poggiato in parte sulla spalliera del divano. Nel II atto il tappeto è allacciato con fettucce a uno stangone e si alza verticalmente come un fondale. Nel III atto il tappeto viene raccolto a tendaggio – vedi disegni – con cordoni da tappezzeria in cotone e seta. Nel IV atto il tappeto copre i mobili.Le garze o tarlantana
Tutt’intorno alla pedana, come copertura alle pareti di fondo e relativi sforamenti laterali, è prevista una serie di strisce di garza bianca. Detta garza deve essere ignifugata per la stessa ragione del velo.
Ogni striscia ha un filo di nylon incorporato lateralmente sulla cimosa per mantenerla dritta e fissata a terra. Le strisce sono applicate su stangoni e fissate a terra tese. Sulla pianta sono indicate le posizioni delle strisce e alcune sono da definire.
Occorre preparare alcuni campioni di strisce in palcoscenico per scegliere la più adatta come grana, colore e misura.Mobili e arredamento
Per il momento si potrebbe iniziare la ricerca (in base alle misure di massima) del biliardo, soprattutto per quel che riguarda il piano, le imbottiture e le buchette per avere il suono.
La parte esterna potrebbe essere ricostruita cercando di rendere il pezzo il più leggero possibile.
Un’altra cosa che si potrebbe cercare è il motore per trenino e treno. La differenza è che il trenino è e risulta un giocattolo, mentre l’altro è un modello del treno vero.
Con i disegni seguiranno le relazioni dettagliate dei mobili.Relazione dattiloscritta datata 9 marzo 1974 – Archivio Piccolo Teatro di Milano; pubblicata in Anton Čechov, Il giardino dei ciliegi, a cura di Luigi Lunari, Milano, Rizzoli, 1974
- Valentina Cortese. In bilico tra disperazione e allegria, tra lacrime e frivolezza
Il Piccolo Teatro è un luogo dove abita la poesia!
A cominciare dal suo cortile attraverso il quale sono passata entrando e uscendo per vent’anni. Questo cortile per me era come un grembo materno, era una cuccia in cui mi rifugiavo ogni volta prima di entrare in palcoscenico, e qui ho sofferto e vissuto tutte le mie ansie, le mie speranze, le mie gioie, i miei tormenti, le mie angosce, le mie paure, i miei trionfi. Trionfi dovuti alla magica poesia di Strehler, di cui questo cortile è testimone da sempre e sembra conservare l’eco degli applausi, fino a rimanerne impregnato, quasi a farli risentire a chiunque lo attraversi. Quel cortile, separato dalla sala del Piccolo da un portico angusto e da un muro secolare, è per me come la cassa di risonanza di un violino. È lì che gli applausi e le emozioni della storia del Piccolo, di Strehler, di noi attori e mia, escono dal palcoscenico dove il nostro lavoro si è creato e vanno in giro per il mondo.
Quanti ricordi! Quanti momenti sublimi e toccanti, quante gioie e quante paure… E le urla entusiasmanti del pubblico. E il ricordo struggente di quelle lontane notti, per esempio, in cui Giorgio Strehler, insoddisfatto delle tante ore di prove, di lavoro duro, improvvisamente si illuminava, si accendeva e, come un prodigio… quasi in uno scoppio di colori e di luci, buttava fuori tutta la sua immensa bellezza interiore, eccezionale, e trasmetteva a noi attori quel suo mondo straordinario, quella sua poesia vissuta intimamente in stretto collegamento con esseri umani e soprattutto con universi sconosciuti ad altri… e noi lì, a seguirlo incantati, affascinati, avvolti da questo fluido fatto di magia, indescrivibile. Lui, il grande Burattinaio, tirava i suoi fili misteriosi e noi, quasi senza accorgercene, ci lasciavamo andare… andare al personaggio, al teatro… con un abbandono totale di fiducia, con un totale sacrificio d’amore… e poi, all’alba, tornavamo a casa leggeri, felici, rinati… appagati.
Ricordo sempre con dolce, grande nostalgia quelle rare notti. Dio, com’era bello il teatro vissuto così! Strehler è stato, per me, il mio Burattinaio e io la sua marionetta, legati da un filo impalpabile fatto di ricordi, di tenerezze, di bufere… di poesia e di tanto amore e di tanto teatro…
[…] Con Strehler ho anche litigato… spesso. Con tanto amore, però, perché lo scopo era lo stesso: fare il meglio possibile. Io del mio personaggio. Lui del suo spettacolo. Con lui il lavoro è vivo, graffiante; è bellissimo creare le cose insieme. Lui ti porta su questo filo di poesia che è indescrivibile.
Con Giorgio ho imparato molto, sia sul piano umano che su quello professionale. Ho imparato con lui a capire più profondamente i personaggi oltre che ad amarli; ho imparato a sviscerarli, implacabilmente, senza rinunciare mai al minimo dettaglio, a pretendere da me stessa sempre il cento per cento, come Strehler dice e vuole da tutti noi. Pretendere il cento per cento per riuscire a dare almeno l’ottanta perché al pubblico ne arrivi almeno il sessanta e perché ne ricordi almeno il trenta per cento. Questo è un po’ il dramma di noi attori: il nostro “scrivere sull’acqua”; e Strehler ci ha insegnato, tra le altre cose, che proprio perché scriviamo sull’acqua dobbiamo lavorare duramente e lottare come se “scrivessimo sul marmo” […].
Che cosa cerco io nei miei personaggi? Che cosa cerca un attore nei suoi personaggi? Quello che c’è. In fondo, in un personaggio si cerca sempre una verità umana: una verità il più possibile profonda, articolata, dialettica e contraddittoria. Sì, contraddittoria: i personaggi più veri sono quelli che si contraddicono con se stessi, che sono divisi in due metà, l’una in lotta con l’altra. Giovanna Dark in Santa Giovanna dei Macelli, Ilse nei Giganti della montagna, Lulu nella Lulu di Wedekind, Liuba nel Giardino dei ciliegi: quattro miei ultimi, più cari personaggi. Tutte donne contraddette. Giovanna, tra fede e conoscenza, amore di pace e scelta della violenza. Ilse, tra la umana modestia del mestiere e la universale grandezza della poesia. Lulu, il bene e il male, la purezza e il peccato, l’aspirazione al cielo e la forza dell’inferno. Liuba, la libertà di essere come si è – con tutti i propri difetti, le proprie debolezze – e il prezzo pagato per esserlo: solitudine, rovina totale. Liuba mi assomiglia, ha tanti miei difetti: butta via il denaro, incosciente, apparentemente superficiale, leggera, infinitamente femminile e che non riesce e non vuole staccarsi dalla sua infanzia, come me. È continuamente in bilico tra la disperazione e l’allegria, tra la frivolezza e le lacrime. Si dà con molta generosità a tutto e a tutti, inconsapevole e a volte anche consapevole dei disastri a cui va incontro, ma tiene gli occhi chiusi, non vuole accettare, non vuole credere, si illude sempre che succeda qualche cosa, un miracolo che la salvi all’ultimo momento. Ma è troppo fragile per lottare fino in fondo e sbaglia con tutti gli esseri umani, sbaglia sempre. È come una piccola rondine che si butta a capofitto nella vita spezzando le sue tenere ali. Nella sua teatralità Liuba raggiunge addirittura momenti deliranti fino allo spasimo e nel suo delirio ci crede, è vera. Lei è tutta teatro, è un personaggio fuori tempo, insomma, vive una sua dimensione di un suo teatro in un mondo diverso dalla realtà. È una passionale dalle lacrime e dalle gioie violente, esuberante nell’allegria quanto nel dolore. Anche se c’è scritto che Liuba Andreievna non deve piangere mai… c’è sempre quella didascalia di Čechov: «Ride tra le lacrime o ride piangendo o piange con un sorriso». Forse Čechov voleva dire che non ci deve essere l’una cosa senza l’altra, al mondo. Certo, fatto così, il personaggio è molto difficile. Con Strehler abbiamo dovuto scegliere la via più impervia e più rischiosa, ma certo la più affascinante. Tutti quelli che si sono chiesti il perché della mia teatralità in questo ruolo… ebbene, ora lo sanno.Valentina Cortese, Una “cuccia” per Liuba spendacciona, in Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e spettacolo, a cura di Maria Grazia Gregori, Milano, Leonardo Arte, 1997
Al Piccolo Teatro debuttai con Čechov e di Čechov fu anche il mio ultimo spettacolo. Strehler aveva già diretto Il giardino dei ciliegi vent’anni prima, ma volle riproporlo con l’interpretazione mia, di Gianni Santuccio, che tutti chiamavano “Ciccetti”, Renzo Ricci, Giulia Lazzarini, Franco Graziosi, Monica Guerritore, appena diciassettenne, e altri bravissimi attori. Fu un’edizione memorabile, sia per la scenografia bianca e allusiva, sia per lo stile dell’interpretazione, in cui il verismo è stemperato e filtrato da accenti simbolici. Io cercai di presentare Liuba con un’interpretazione elegiaca e malinconica, con pause, sfumature, sospiri, grandi gesti delle braccia, mantenendomi comunque su registri velati, leggeri e minimali. Liuba è un personaggio russo, tutto sul filo del rasoio, che si butta nelle cose, che quando dà affetto ne dà fin troppo e quando si dà, si dà tutta. Una creatura un po’ zingara, un po’ migrante, come lo sono stati molti russi. […]
Tornare a lavorare con Giorgio è stata una grande gioia. Lui mi portava a una poesia indescrivibile, tirava fuori il massimo. In quell’edizione dei Ciliegi lasciò noi attori molto liberi. Lui non faceva che metterci sul binario giusto e noi quasi non ci accorgevamo delle cose che ne scaturivano. Tra le qualità di tutti i registi con cui ho lavorato, a Giorgio riconosco la capacità di impostare il lavoro prima di tutto, di creare l’atmosfera.
[…] Il Giardino l’abbiamo portato in tournée in numerose città italiane e, tra il settembre e l’ottobre 1976, fummo in scena anche a Parigi. Un trionfo. Finito lo spettacolo la gente cominciò a entrare nel camerino per farmi i complimenti, ma io ero stanca e non avevo la forza di seguirli: a un certo momento uno di loro mi abbracciò senza darmi il tempo di vederlo in volto e mi disse delle parole così belle che mi chiesi chi fosse. Mi scostai e lo guardai in faccia. Era Peter Brook e gli dissi: «Rimetti giù la testa sulla mia spalla e ripeti le stesse cose».Valentina Cortese, Quanti sono i domani passati, a cura di Enrico Rotelli, Milano, Mondadori, 2012
- Monica Guerritore. Terrorizzata dal grande Maestro
È stato per un puro caso, come succede per i grandi fatti della vita. Ero tornata a Roma dalla Svizzera, dov’ero in collegio, e una mia amica che frequentava una scuola di teatro aveva saputo di questo provino a Milano con Strehler, cercava Ania del Giardino dei ciliegi. Decisi di accompagnarla e subito dopo proseguire per la montagna. Arrivate alle tre di pomeriggio in via Rovello, vedemmo che il cortile era strapieno. Allora non c’era tanta tv, le ragazze con la vocazione d’attrice partivano dal teatro o dal cinema a Cinecittà.
Per entrare ho finto di star male, così abbiamo saltato la fila. In portineria abbiamo approfittato di una distrazione e siamo entrate, abbiamo girovagato un po’, siamo scese da una scaletta e ci siamo trovate in quinta. A quel punto sentiamo: «Dietro altre venti», e siamo entrate anche noi. Io avevo un impermeabile e la valigia, proprio come Ania. Sembrava l’avessi fatto apposta. Ci ha fatto muovere un po’, correre sul palco. Non lo vedevamo, era in platea e c’erano le luci. Poi grida: «Andate via, resta solo la ragazzina con la valigia e i capelli corti». Ero io.
[…] Mi ha chiesto cos’avevo portato, e io: «Niente». Mi ha cacciata in malo modo, però l’aiuto regista, Carlo Battistoni, aveva filmato tutto. Io me ne sono tornata dai miei amici e ho raccontato ridendo di aver conosciuto un pazzo. Tornata a Roma, dopo tre-quattro giorni mi chiama uno di questi amici e mi dice che sul Corriere era uscito un articolo: «Strehler non inizia le prove del Giardino se non trova quella ragazzina romana con la valigia che assomiglia alla Bergman, di cui però non sa né nome, né cognome, né indirizzo, si sa solo che andava a sciare». Mia madre mi dice: «Chiama». Mi risponde Franceschinis, il portiere, che mi passa Nina Vinchi: «Venga immediatamente, per carità». Ho ripreso il Settebello e ho aspettato. Avevo appuntamento alle tre, è arrivato alle sette.
[…] Mi fa: «Ciao, Ania». Io l’ho corretto subito: «Mi chiamo Monica». Lui s’è messo le mani nei capelli: «Che disastro». A una mostra a Trieste vidi i suoi diari, aveva appuntato: «Vista oggi una ragazzina deliziosa che assomiglia alla Bergman. Speriamo che sappia parlare.»
[…] Io non avevo nessuna intenzione di fare l’attrice. Lui ha intuito che avevo qualcosa, e mi ha fatto stare tanto in palcoscenico. Mi faceva solo muovere sul palco, senza mai dire battute. Era un genio, e con me si è rapportato in maniera geniale. Quando non ero in scena mi faceva mettere seduta dietro di lui. Il mio amore per il teatro è nato guardando come il palcoscenico si riempisse di ombre, di luce e controluce: era un regista cinematografico ancora prima che teatrale. Ha creato la scena come spettacolo del mondo, ha tolto il realismo e ha messo la metafora. Guardandolo ho introiettato cosa volesse dire il corpo in scena.
Quando arrivava c’era grande tensione, le prove iniziavano alle tre del pomeriggio e non c’era orario di fine. Si iniziava con Battistoni, Puggelli e D’Amato, i suoi tre assistenti. Poi a un certo punto si creava uno strano silenzio: stava arrivando lui. Preceduto dal tè che gli portava la Teresa, la signora del bar di sotto. Cominciava a rodare, parlava, parlava, metteva le luci, la musica, poi due-tre ore solo di movimento, di ombre, di immagini: per questo dico che è stato il più grande regista cinematografico del teatro. Poi iniziava a definire, raccontare le scene, in maniera così viva e profonda, la malinconia, la tenerezza, e tu entravi in un’estasi, eri veramente in uno stadio fuori dalla realtà. Dopodiché bisognava mettere a punto, e le cose dovevano essere perfette. Lì non cedeva di un dito, poteva urlare, incazzarsi. Una notte capitò a me.
[…] Mi chiama: «Adesso facciamo la grande scena di Ania che consola Liuba», che era Valentina Cortese. Un lungo monologo, subito dopo che è stato venduto il giardino dei ciliegi. Dovevo correre verso mia madre e consolarla. Me lo ha fatto fare una, due, tre volte; ha cominciato a strillare: «Non corri, non sai correre, non sai dire le battute, rifallo!». C’era Valentina che mi diceva: «Non ti preoccupare, resisti. Lo fa apposta, non piangere». Io ho cominciato a piangere come un vitellino, ho buttato i costumi di scena, ho preso la bicicletta e me ne sono tornata in albergo. Mi ha spezzato. Era mezzanotte, ho chiamato mia madre: «Io torno a Roma, non ce la faccio». Subito dopo mi ha chiamato Strehler: «Prendi la bici e vieni qua, ti aspetto nel mio ufficio». Io ho preso il mio copioncino e sono andata. E li è successo qualcosa. Nel momento in cui il cuore è esploso dal dolore di quella umiliazione, si è rotta una barriera. Io ero disarmata davanti a lui, e lui lì, goccia a goccia, ha creato una complicità, mi sentivo compresa, e potevo osare. Ero cambiata come una crisalide, sbocciata a nuova vita. La ragazzina stava diventando un oggetto d’arte. Strehler ti fa fare un salto, ti fa entrare in un mondo dove ogni personaggio disegna una parte precisa, contribuisce a comporre la forma perfetta.Intervista di Simona Spaventa, riportata in Strehler. Il gigante del Piccolo, a cura di Sara Chiappori, Torino, GEDI – Gruppo Editoriale S.p.A., 2021
Io non sono impaurita da Strehler. Sono semplicemente terrorizzata. Ieri mi sono messa a piangere. È stato come se mi fossi liberata da un blocco. Oggi vado già meglio. D’altra parte, con Strehler non ci sono mezze misure. Lui mi ha detto: «O riesci a tirar fuori qualcosa o te ne vai». Ora sono sicura di farcela. Da un mese a questa parte è stato tutto un periodo di crisi. Sapevo benissimo di non dare tutto quello che potevo. Adesso ci riesco e ho scoperto che per me il teatro è tutto. […] Cosa provo per Strehler? Tanta tenerezza, perché è veramente un grande uomo, ogni cosa che fa ti rimane dentro…
Riportato da Paolantonio Pagani, C’è anche un barboncino che fuma e dice «papà», “La Notte”, 12 aprile 1974
Giorgio.
Questo è il nome che mai sono riuscita a pronunciare. Quel groviglio di sentimenti che a distanza di ventidue anni riaffiora dal fondo del mio cuore si snoda ora attraverso queste parole che danno forma piccola a pensieri mai detti in tutti questi anni. La timidezza di quella bambina davanti al grande, bellissimo maestro, è la stessa di allora e mi ha impedito, in tutto questo tempo, un gesto, uno scritto, un abbraccio forte di amore e di gratitudine. Prendo coraggio e le parlo ora pubblicamente, essendo, a 37 anni, compagna e amica di quella bambina, ma anche donna consapevole e matura.
Era il 1974, lei preparava una grande edizione del Giardino dei ciliegi e cercava una piccola attrice per interpretare il ruolo di Ania, la figlia di Liuba. Si presentarono a mille e il destino mi portò al Piccolo. Accompagnavo una mia amica e lei mi prese per mano e mi disse: tu resti con noi. Mi sono ritrovata per lunghi mesi accovacciata in una platea buia, seduta in una poltroncina proprio dietro di lei. Ricordo il grande rigore, il silenzio assoluto. Il palcoscenico si attraversa in punta di piedi e io che correvo. Multa! Non ci si siede sulle sedie quando sono in scena. Multa! Valentina Cortese e il caro Gianni Santuccio. Si ricorda quando si portò il vestito di lino da casa perché gli stava meglio del vestito di scena? Il grande Renzo Ricci, Giulia Lazzarini creavano pian piano i loro personaggi. Piangevano e ridevano, lei tirava fuori dal fondo della sala buia tutti i sentimenti chiusi nelle loro anime. Poi toccò a me. Mi insultò, mi violentò con delle parole così feroci che provai per la prima volta nella mia vita un dolore così grande che sembrava spaccarmi il cuore, e in quella breccia, tra le mie lacrime, lei versò poesia, umanità. Quello che lei mi stava dando era una ricchezza immensa e ho giurato a me stessa che mai l’avrei tradita. Non ho fatto fatica a tenere fede a quel giuramento.
Ora dopo ventidue anni affronto lo stesso testo, Il giardino: con molta umiltà sarò nel ruolo della grande Valentina Cortese. Ed è in questa occasione che le scrivo, perché questa piccola vita cambiata possa avere un senso per i giovani che leggeranno queste righe. Ho usato parole e raccontato fatti che sembrano lontani anni luce dal linguaggio corrente della nostra società. Ho trattato un tema, il teatro, che si vuol far credere secondario rispetto ai bisogni urgenti del nostro vivere civile, mentre forma, attraverso i capolavori, gli attori e i registi, la nostra vera coscienza civile. Nel caos, nel buio dei nostri anni che ci portano al Duemila, maestri come lei potrebbero insegnare a milioni di giovani, come a me, a credere nella bellezza dell’uomo e a non avere paura. Questa è la cultura che restituisce a ogni essere umano la sua grandezza, l’amore in se stesso e la sua unicità. E crea uomini pensanti e forti.Monica Guerritore, Mio caro Maestro, lei mi spaccò il cuore, “La Repubblica”, 6 agosto 1995
Rassegna stampa
- Una semplice e razionale poeticità
Con un applauso durato venti minuti, con ovazioni ai singoli interpreti, evocati alla ribalta uno per uno e tutti insieme, con una entusiastica approvazione al regista Giorgio Strehler e al suo scenografo Luciano Damiani (tornato dopo anni a lavorare con lui) si è conclusa […] l’anteprima del Giardino dei ciliegi di Anton Čechov, riallestito in un’edizione notevolmente diversa da quella del 1955. Il realismo di Strehler ha qui fatto due passi innanzi: dall’accumulare in scena gli elementi visibili dell’ambientazione della commedia è passato a una scena nuda; dal mettere in mostra, fisicamente, i meravigliosi ciliegi del giardino di Liubov Andreievna è approdato a un’altra immagine simbolo-emblema e “trovata” di teatro, e macchina lieve, aerea, vaporosa e pregnante, al grande velario che fa da sipario e da “cielo” al palcoscenico e a metà della platea.
Questo velario assume di volta in volta valori diversi a seconda dei vari momenti dell’azione, da mera chiusura dello spazio scenico all’inizio degli atti, a soffitto d’interno, a momento della natura, mutabilissimo per i brividi che lo percorrono, cielo della campagna russa attraverso il quale vanno i segreti rumori di una vita “al di là”, “al di fuori” della piccola malinconica esistenza di quel nido di nobili estenuati dalla vita.
Nella scena finale, tutto l’apparato artigianalmente perfetto del cielo si cala sopra i mobili della casa, e copre il corpo del vecchio Firs, indicando così una condanna del decrepito passato già espressa dalla chiusura delle imposte e dalla derelizione di quella cariatide umana eternamente condannata al servilismo, ma ribadita con un’immagine che aggiunge il concetto del crollo definitivo di un mondo. Poi, di colpo, esce la giovane attrice, la debuttante Ania (Monica Guerritore) a salutare e a ringraziare gli spettatori, e calpesta quel cielo, e su di esso si erge nella sua fresca semi-adolescenza. La gioventù ha vinto e vincerà sempre. Il velario qui risale di nuovo, pieno di luce: diventa quasi una lastra di vetro luminoso, mentre si odono, dentro, i canti e i rumori dei tagliatori del giardino dei ciliegi. Senza forzature, lo spettacolo ci dice in tal modo quel che nella storia degli uomini sempre avviene nella lotta tra vecchio e nuovo, tra reazione e progresso, visivamente affermando il secondo contro la prima.
Il realismo di Strehler si è dunque liberato, nel mettere in scena Čechov, delle scorie naturaliste, presenti ancora nel 1955: esso ci narra la favola del Giardino non già come intimistico sfogo del poeta e dei suoi personaggi, come insieme di silenzi e di pause, come lirica presenza dell’inespresso, come manifesto del pessimismo, ma come momento della dialettica della vita, inestricata compresenza di positivo e di negativo, di bene e di male, di luce e di buio, di collettivo e individuale. E quindi anche di comico e di tragico, di vaudeville e di dramma; il tutto calato in una spettacolarità casta, senza orpelli, dai tocchi lievi, dalle indicazioni accennate.
La lezione di Brecht è anche qui presente, dunque: nell’esaltazione del valore dialettico dei “segni” drammaturgici che esprimono il dolore e la gioia, il ridicolo e il serio, nell’accenno al significato di sintesi che assumono, qui, i proletari presenti nell’azione; il passaggio, ad esempio, nel secondo atto, del viandante che invece di essere un mero portatore del folklore russo diventa quasi un piccolo personaggio gorkiano. E Strehler ha inventato, in più, la sua parlata in russo, dilatandone la battuta cecoviana, in modo che nella sua apparizione senti, più che la sottomissione popolare, il preannuncio della rivoluzione. Più evidente ancora appare tutto ciò nel coro finale dei tagliatori al lavoro: essi abbattono i ciliegi per il capitalista Lopachin, ma intanto senti che cresce in loro la solidarietà e la coscienza di una classe nuova, che caccerà capitalisti e aristocratici.
In questo senso si trova risolto anche l’utopismo dello studente Trofimov, impasto di visionario e di democratico che vede il riscatto in un lontano futuro e dice di operare per esso, ma concretamente nulla o poco fa, e quel poco solo in un’azione individuale; il che non toglie nulla ai valori positivi della sua classe e della sua età. Ogni personaggio presuppone dunque un’analisi di classe attenta e determinante; il richiamo alla classe è sempre presente, anche nei personaggi di una tipologia minore (il possidente in rovina, il contabile, il giovane servitore più scaltro del vecchio Firs ma non meno perduto, la cameriera Duniascia, la governante Charlotte: una piccola umanità contraddittoria), ma il tutto si risolve in un’armonia e in un equilibrio perfetti.
Armonia ed equilibrio che risultano evidenti soprattutto nel personaggio di Liubov Andreievna e di Gaiev: Valentina Cortese ci ha restituito sulla scena la sua signora infatuata dell’amore che ha pagato di persona con umiliazioni e miserie, di una poetica immaturità sentimentale e sociale ma piena di slanci, generosa e incapace, volubile ma dotata di una carica affettiva illimitata. Passa dal riso al pianto, da momenti di depressione a momenti di gioia, di allegria, con estrema facilità.
Si pensi solo alla grande invenzione di Čechov di far svolgere nella casa che va all’asta la festicciola: mentre il destino si compie altrove, quell’umanità mediocre si rallegra ballando. Questo contrasto è ben sottolineato nella regia: che non disperde l’attenzione tra mobilia russa e samovar, ma è tutta concentrata nella scena spoglia, contenente alcune sedie per gli spettacolini offerti dalla governante Charlotte, ammaestratrice di cani e prestidigitatrice. Liubov Andreievna-Valentina Cortese trascorre le ore dello svago come un’eterea creatura di un’estrema sensibilità, alternando le amare riflessioni con gioiose esplosioni, fino a quando la notizia che la casa è stata comprata da Lopachin col suo giardino non la annichila, e lei non sa se piegarsi su se stessa e piangere.
Gaiev è Gianni Santuccio, di cui dice con partecipazione il senso di nullità, il facile ricambio della speranza che si illude, la debolezza morale e la bontà. Piccolo topo di casa, nella sua conduzione degli affari domestici, tra una cambiale e l’altra, è la Varia di Giulia Lazzarini, personaggio descritto con abile lavoro di bulinatura, inteso, anche questo, a mettere in luce il suo positivo e il suo negativo. Esemplare la scena in cui non riesce a “comunicare” con Lopachin, e il matrimonio con lui sfuma; del resto le sue aspirazioni sono poche e limitatissime, cento rubli e andare in giro per la Russia in pellegrinaggio…
Di tutto risalto è il Lopachin di Franco Graziosi, nipote di un servo della gleba, che considera l’acquisto del giardino come una sua revanche di classe, che ha la brutalità dei neocapitalisti, ma al contempo è uomo savio e prudente, innamorato del suo lavoro. Qualità e difetti sono messi in risalto da Graziosi con una recitazione asciutta, limpida, di sicuro effetto. Piero Sammataro è Trofimov ed è di perfetta misura, dandoci insieme un po’ l’infantilismo della sua utopia, ma anche la generosità di essa e la velleità di attuarla o, per lo meno, di voler contribuire ad attuarla. […]
Ania è la debuttante Monica Guerritore, che ha affrontato spavaldamente la parte: può essere un pericolo, per quanto qui non abbia fatto sentire nulla di acerbo nella sua recitazione fresca e simpatica. […]
Firs è Renzo Ricci: gli applausi che gli sono andati lo hanno premiato per una presenza autorevolissima in scena, la presenza di un vero maestro per tutti i giovani, di disciplina, di bravura, di attaccamento alla parte. […]
Lo spettacolo, nel suo insieme, è stato in continuo crescendo: esso si presenta, dunque, come una poetica riflessione sulla dialettica del vivere, sulla pena e sulla gioia dell’esistere, senza le discese agli inferi esistenziali, ma con la lucida coscienza critica, del senso lancinante e bellissimo del mutamento. Esso recupera, anche linguisticamente (la traduzione è dello stesso Strehler e di Lunari), un Čechov un po’ desueto: il Čechov scabro narratore, essenziale estensore di dialoghi, in cui davvero il gioco psicologico ha parte relativa, mentre sale d’importanza il comportamento dei personaggi. Formalmente, la rappresentazione è asciutta, tutta giocata sulla significazione molteplice di segni, come il grande velario, la luce bianca usata quasi in permanenza in controluce, gli spazi vuoti, il grande parterre che, di volta in volta, è il pavimento della casa o la terra della collina, il trenino che passa, piccolo piccolo, come i personaggi lo vedono o proiezione dei loro desideri. I costumi sono anch’essi bianchi, usati dal tempo, curati con particolare attenzione da Damiani che ha fornito a Strehler l’appropriata “macchina per recitare”, dove la nota dominante è quella di una poeticità semplice, lucida e razionale.Arturo Lazzari, “l’Unità”, 23 maggio 1974
- Sotto un’ala di gigantesca farfalla
Il velo-giardino, il velo che è insieme spazio e tempo, stagione, cielo e foglie, il velo che dal fondo della scena sale all’arco della ribalta e di là si protende, membrana leggera, ala di gigantesca farfalla, sulla platea: questa è l’invenzione di base, strutturale, del nuovo spettacolo di Strehler, di questo Giardino dei ciliegi andato in scena con grande successo ieri sera. È una di quelle immagini, semplici e potenti, che sono destinate a restare, e che non solo fanno da sigla a una serata di teatro, all’interpretazione registica di un testo; ma che valgono di per sé come condensazione di elementi figurativi e lirici appena suggeriti, soffiati attraverso il varco stretto, irripetibile di un’intuizione. Elemento poetico e scenografico, cifra di un’interpretazione emblematica, questo velo-giardino, questa sintesi di spazio-tempo, è anche il risultato più sensibile – e vistoso – del rinnovato incontro Giorgio Strehler - Luciano Damiani, cioè del ricostituirsi di un binomio che ci ha dato molte di queste indimenticabili metafore visive.
[…] Strehler, come già s’è detto, affronta i grandi testi del teatro nella globalità dei loro differenti piani; tenta di darne la versione classica, totale, ma andando sotto ai significati delle parole, collegando la sua ricerca a ogni minima indicazione dell’autore, rompendo le parentesi in cui sono chiuse le didascalie per immetterne la descrittività non soltanto negli elementi scenografici (interpretati, naturalmente; resi, come qui, stilizzati e astratti), ma anche nella recitazione e negli atteggiamenti mimici degli attori.
Così, questo Giardino nasce col ritorno di Liubov Andreievna Ranievskaia alla casa natale, dopo che una vita di passioni disperse è passata […], come rientro in un grembo materno, attraverso il limbo bianco dell’infanzia. Non per nulla, Čechov fa avvenire tale ritorno in quella che è stata sempre chiamata la camera dei bambini. Ingigantendo l’indicazione e rivestendola anche di un suo personale sentimento del tempo perduto, Strehler immerge questo primo atto nell’albume della memoria, fra mobili minuscoli, lillipuziani banchi di scuola, un sofà e il grande armadio secolare davanti al quale Gaiev tenta una delle sue patetiche variazioni oratorie.
Siamo come dentro un uovo, in una sostanza cieca e abbagliante, nella patetica e un po’ dolciastra indistinzione dell’infanzia, un prolungamento della consapevolezza prenatale. A un certo punto, il vecchio armadio scoppia: le ante si aprono e, in una nuvola di polvere – i giorni macinati –, ne scaturisce una cascata di antichi giocattoli, di globi colorati per l’albero di Natale e una carrozzina da bambini, forse quella che servì per il piccolo Griscia, il figlio morto di Liubov.
Ma sbaglierebbe, a nostro parere, chi volesse da simili immagini dedurre che tutta questa rilettura del Giardino dei ciliegi si svolga sotto il segno, psicanalitico, di un regresso all’infanzia. Certo, il lirismo tinnulo e crepuscolare dei giocattoli, la musica da carillon che echeggia in un’alta soffitta della memoria, fra le spoglie smesse del tempo che fu, si prolungano con un po’ di compiaciuta insistenza nello spettacolo. Ma diventano tema di fondo solo nella misura in cui riescOno a esprimere il rifiuto della società di Liubov e di Gaiev, la società degli oziosi ricchi al tramonto, a inserirsi nella realtà nuova, che non è solo quella del mercante Lopachin, il figlio di antichi servi che acquisterà il giardino dei ciliegi.
E infatti i temi interpretativi si moltiplicano nel secondo e terzo atto; in quel secondo atto in cui, su una sorta di astratta piattaforma bianca, rilevata sul fondo a fungere da prato in salita, in un’aria da colazione sull’erba, si gioca la partita dell’apatia turbata, ma non riscattabile, di Liubov e Gaiev, dell’amaro attivismo di Lopachin, della speranza giovanile di Ania, della fiducia indistinta e febbrile di Trofimov. E allora il treno che passa sul fondo, immagine come evocata in sogno, ma reale, e il suo doppio, in primo piano, il trenino-giocattolo che scorre traballando ai piedi dei personaggi, diventano il segno che fa da cerniera fra la realtà del presente, il futuro in cui scava quel roco fischio perduto nelle distanze, e la memoria del passato, arrotolato su se stesso in una posizione fetale.
A quel punto, il tempo dello spettacolo e il tempo storico sono maturi per il sobbalzo profetico indicato nel testo da quel rompersi come d’una corda di violino, da una sillaba musicale; che Strehler rende con un silenzio lungo, un soprassalto rabbrividito dei personaggi e il palpitare e il gonfiarsi del velo che è insieme spazio e tempo, cielo e stagione. Poi il regista fa passare il viandante-mendicante in tuta operaia; e lo fa parlare, melodico e come ebbro, in russo. È un messaggio affondato negli anni a venire, che nessuno di quella gente può ancora comprendere. Alto momento di teatro, uno dei culminanti della serata.
Allo stesso livello diversi punti del terzo atto, tutto preso nel vortice – un-due-tre – di quel valzerone inventato da Carpi, simile a uno spumante da pochi soldi ma che basta all’oblio di chi vuole per forza sbalordirsi nell’attesa dell’evento temuto; e dove strazio-riso, quell’altalena di angoscia autentica e di assurda allegria che Čechov intendeva per vaudeville, si esprimono in una recitazione nevrotica, frusciante, volubilissima. Il mormorio nella foresta: una foresta di nervi. Poi, a conclusione di uno spettacolo che i suoi momenti migliori li ha nel secondo e terzo atto, il finale vagamente beckettiano del quarto, col vecchio servo Firs già avvolto nei sudari della casa-tomba.
Strehler ha voluto una recitazione immedesimata ma non naturalistica, onirica ma reale, “buttata via” ma sedimentata nei suoi umori patetici e grotteschi […]. Valentina Cortese assorbe su di sé, come Liubov, il carico più pregnante, ma anche il più impegnativo, di questa ipotesi di voce-vita, di parola-istante; e lo rende altamente nei molti momenti felici, anche se ogni tanto cede a un’ombra di manierismo (che forse è, visto criticamente, anche il manierismo che si è voluto attribuire a questa figura). È perfetto Gianni Santuccio nella presenza-assenza di Gaiev, in quel suo inerte constatare e nel desolato rifugiarsi nel piccolo tic-evasione del personaggio: lo schiocco della stecca sulla palla del biliardo. Franco Graziosi è un Lopachin nuovo, dolce e sovraeccitato insieme. Il Trofimov di Pietro Sammataro, così vibratile e intenso, è una prova dell’alta maturità ormai raggiunta da questo giovane attore; e la deliziosa, musicalissima Lazzarini, come Varia, è un soffio di vane lacrime, un arruffio di gesti nevrotici. L’esordiente Monica Guerritore, Ania, riesce a trasformare quasi sempre la sua acerbità d’attrice in freschezza e immediatezza di istinto.
E bisogna ricordare l’umorismo indispettito di Gianfranco Mauri, la patetica comicità di Enzo Tarascio, la souplesse mimico-vocale di Claudia Lawrence […]. A parte, perché davvero se lo merita, Renzo Ricci, che è un Firs indimenticabile, fantasma della fedeltà e della tetra dolcezza, con nella voce, al finale, l’umile indifferenza dell’eterno. E infatti, il pubblico lo ha acclamato a lungo, quasi avesse riscoperto lo straordinario attore.
Quanto all’esito dello spettacolo, del resto, sia all’anteprima sia ieri, un trionfo.Roberto De Monticelli, “Corriere della Sera”, 23 maggio 1974
- Una ballata di fantasmi
Dove si svolge questo Giardino dei ciliegi? La scena – stupenda realizzazione di Luciano Damiani – ci offre, su un fondale neutro, uno spazio centrale: dove al primo atto si scoprono le seggioline, i servizietti, i giochi dei bambini, che i personaggi furono (o sono?), e l’armadio centenario; che, al secondo, è uno scosceso declivio; dove, al terzo, di nuovo un telone si stende sui mobili inutili e cela i bagagli per l’imminente addio. Al di sopra, un telo leggero e mobile, largo quanto il boccascena, avanza e copre mezza sala, ora alitando nel vento dei trasalimenti, ora calando a sudario di quella realtà. È il giardino e la casa insieme, è il tempo e l’eternità, è l’onda di un cielo calmo d’avvertimenti, ma impassibile; gronda foglie secche e aspetta preghiere diverse, altri uomini. Ma è anche, nel suo candore che ripete quello della scena, dei mobili, delle vesti (il nero è dei camerieri), un ventre e – i polisensi sono probabilmente un gioco al quale si è invitati – lo spazio della memoria e la stanza del passato, dove Liubov e Gaiev corrono a rifugiarsi, cercando difesa in un’impossibile restituzione di sé all’innocenza protetta dell’infanzia. In questa camera dei bambini interiore ed emblematica, Strehler confeziona tutta una sinfonia o, meglio, un’intera ballata di fantasmi. Il senso dell’apparizione, in effetti, che è un segno di un non vivere, di una non realtà, mi sembra precipuo nell’orditura delle entrate, delle uscite, dei passaggi (vedi quelli di Firs, ad esempio). Ed è, altresì, in questo luogo, dove i protagonisti tornano, ma dal quale non si sono poi veramente allontanati mai, che si celebra un piano giudizio, e si dà sentenza d’esilio. Esilio nel vento frontale del quotidiano, quando appunto il presente irrompe nel frastuono delle seghe e delle scuri. Come se fosse avvenuta una seconda generazione.
In questo clima astratto e magico, creato ora dai personaggi come proiezione dei loro stati d’animo e della loro condizione ed ora provocato dal regista a distacco da ogni gancio naturalistico, esplode una figuratività estremamente limpida, e si dipana una cadenza di costante, puro lirismo. È la poesia totale del teatro, la sua parola onnicomprensiva e unica. Aliena da corrive tipologie, da inframmettenze ideologiche, da aneddotiche di mestiere. È l’evocazione e il sogno, il brivido dell’universo e il riso, e insieme le lacrime, delle cose.
[…] Basterebbe ciò che Strehler ha chiesto a Renzo Ricci, e che costui gli ha dato, per pagare l’intero spettacolo. Il Firs del grande attore risulta di straordinaria potenza: è come la figura disseppellita e petrosa d’un sopravvissuto, che muore la propria morte e quella di un’epoca. Ricci si incarna nel personaggio, scoprendone la somma, ignara tragicità. Ed è stato per lui un trionfo. Pure mirabile Gianni Santuccio, in un Gaiev affatto alienato, dolcissimamente umano e terribilmente inerte. Terzo punto di forza il lucido, mordente, Trofimov di Piero Sammataro, la cui integrità espressiva si avvalora per arte di “levare”. E Franco Graziosi sostiene benissimo la doppia anima di Lopachin, concedendo anche quella parte di istrionesco che è nel personaggio. Valentina Cortese imprime in Liubov una vibratilità malata, sottolineando tutto ciò che di infantile spensieratezza il personaggio porta con sé, e il suo bisogno di continui appoggi nell’affetto carezzoso degli altri.Odoardo Bertani, “Avvenire”, 23 maggio 1974
- Una scena toccata dalla bacchetta magica di Luciano Damiani
L’apporto essenziale di Damiani (e dunque di Strehler) è una capacità prodigiosa di sgombrare il campo, di procedere verso una vera liberazione dello spazio, dello spazio esterno e interno, di stabilire dei legami naturali e profondi tra la luce e i personaggi. Una scena che è stata toccata dalla bacchetta magica di Luciano Damiani è una scena ringiovanita, risanata, una scena da post diluvio, pura e che respira a fondo, in cui le attrici e gli attori sono come degli indigeni su un’isola, e dove la pièce è in mare aperto e può intonare ciò che vuole; questo è molto bello e, se non si può ottenere questa freschezza, questa giovinezza di spazio, che al prezzo di una eleganza forse troppo sensibile, tanto peggio, o tanto meglio.
Segnaliamo, inoltre, che la tabula rasa di Damiani resta fedele alle intenzioni dell’autore. Per esempio, Čechov ha detto e ridetto che teneva espressamente che la casa del Giardino fosse «molto grande», e di un’apparenza fragile, ma che bisognava che mobili fossero di una «solidità straordinaria», e che questo si veda. Ed è esattamente ciò che ha fatto Damiani.
[…] Il giardino dei ciliegi del Piccolo Teatro di Milano resta una cosa di gran classe, bellissima. Non è dato spesso, qui, uno spettacolo di tale dimensione. Le nostre donne e i nostri uomini di teatro dovranno soprattutto osservare, ancora una volta, come Damiani e Strehler “liberano” lo spazio teatrale e creano un’aria immateriale dove lo spirito dell’opera è libero; è questo che è bello e potente.Michel Cournot, “Le Monde”, 12-13 settembre 1974
- Una sinfonia in bianco
Una sinfonia in bianco, Il giardino dei ciliegi di Čechov, con la regia di Strehler, al Metastasio. Una sinfonia in bianco, il cui tema è costituito da quell’immenso candido velario che un palpito improvviso tramuta in lirica immagine delle chiome fiorite dei ciliegi e in muta aerea postilla all’azione scenica: una nuvola che si gonfia e si affloscia, si impenna e ondeggia, piovendo sui personaggi stanche foglie distaccate da immemorabili rami. Bianche le pareti delle scene d’interno, bianco l’argine su cui si svolge il secondo atto in un clima da Déjeuner sur l’herbe. Bianchi i costumi in una scala di sfumature sottili, quasi impercettibili, che vanno dal bianco-rosa al bianco ghiaccio, così da rendere più perentorio il contrasto con gli abiti neri della servitù.
[…] Poche volte una regia teatrale si presterebbe a un’analisi tanto complessa da superare i limiti della normale recensione. Ma vorrei non tralasciare l’accenno ad alcuni momenti particolarmente intensi dello spettacolo, fra i quali inserirei subito quel viandante che al secondo atto viene a turbare con la sua sola presenza il clima pigro del pomeriggio di vacanza. Strehler lo fa parlare in russo. E ciò sembra creare uno strappo, acre, nel ritmo della rappresentazione: ma a me è sembrato che solo così, facendo lo spettatore direttamente partecipe di un senso di sorpresa e di sconcerto, sia possibile rendere l’idea della sorpresa e dello sconcerto che provano i personaggi. Né vorrei dimenticarmi di sottolineare come la famosa vibrazione che all’ultima scena del quarto atto annuncia il taglio dei ciliegi (soffocando le parole conclusive di Firs dimenticato nella casa ormai chiusa) sia stata da Strehler preannunciata durante tutto il corso della commedia attraverso una serie finissima di indicazioni: la trottola, il fischio del trenino, il suono metallico dei giocattoli a carica, tutti preludi a quello scatenarsi d’inferno che sopraffà l’ansito atroce del servo abbandonato («E la vita è passata così… e io non l’ho neanche vissuta»).
Fuori di ogni richiamo naturalistico questo Giardino dei ciliegi? Sì, certo, per quanto riguarda la scenografia stupenda di Luciano Damiani, per l’intensità lirica delle suggestioni: ma quale rigore nella recitazione, quale verità nel tradurre sentimenti emozioni slanci ribellioni accettazioni passive. Lo so che non si può parlare di naturalismo nel senso stretto della parola, ma è anche vero che Strehler ha della lezione naturalistica saputo cogliere il meglio, spogliandolo di ogni superficialità, spogliando di ogni effetto epidermico l’immedesimazione degli attori e dandoci così una nuova luminosa lezione di teatro.
Valentina Cortese è Liuba e ne trasferisce sulla scena gli sbalzi d’umore, i ripiegamenti amari e le illusorie fantasie in una gamma generosa di emozioni sofferte. Mai visto un Leonid della potenza espressiva di Gianni Santuccio: dire straordinario è forse poco, tanto egli sa rendere con ammirevole sobrietà il vuoto di questo personaggio desolante. Quanto a Renzo Ricci, il suo Firs è da antologia: fantasma di un mondo sepolto, umile e altero, il vecchio servo prende corpo grazie al magistero dell’attore con una gradualità potente, fra sordi brontolii, evocazioni svanite, rauchi rimbrotti, supina accettazione del suo destino.
Un Lopachin tanto più insolito quanto più è reso in una sorta di sovraeccitata tensione passionale ce lo dà il bravissimo Franco Graziosi; e la musicale, delicata Varia di Giulia Lazzarini è un piccolo gioiello, mentre la giovanissima Monica Guerritore fa fremere di spontanea freschezza la figura di Ania; Piero Sammataro è Trofimov e dà la misura di una maturità artistica nel rapido, asciutto disegno dello studente perpetuo; Gianfranco Mauri raggiunge in Epichodof una comicità amara di grande qualità; ottimo è Enzo Tarascio nelle vesti dello smanioso, buon Piscik; e ancora vanno ricordati lo spavaldo Cip Barcellini, la patetica e pepata servetta di Marisa Minelli, la fantasiosa Claudia Lawrence, Vladimir Nikolaev e Guido Verdini.
Le belle musiche di Fiorenzo Carpi e la lucida traduzione di Luigi Lunari e dello stesso Strehler sono da annoverarsi tra i pregi dello spettacolo, che ha ottenuto un successo veramente trionfale.Paolo Emilio Poesio, “La Nazione”, 5 gennaio 1976
- La poesia in scena
L’edizione del Giardino dei ciliegi di Čechov, curata da Giorgio Strehler per il Piccolo Teatro di Milano e da ieri in programma all’Argentina, riporta sulla scena qualcosa che da troppo tempo non avevamo il piacere di incontrare: la poesia. La parola è grossa, e, per la desuetudine, persino un poco impudica. Ma va detta almeno per economia: per indicare con una parola sola il contrario di ciò che di solito vediamo. Vediamo infatti, assai spesso, la caricatura del testo letterario, o una sua stenta e artrosica interpretazione, o un suo ricalco, pesante e sgraziato, che sta all’originale come le copie di quadri, che le vecchie straniere dipingono nei musei, stanno alle pitture di Leonardo o del Botticelli. Né mancano coloro, più intraprendenti, che ritoccano il testo, per sollevarlo alla loro supposta statura. […]
Il colore di questo Giardino è il bianco. È partendo da questa intuizione che Strehler interpreta con animo artistico, filtra la sua lettura del testo, del resto rigorosissima (la traduzione è sua e di Luigi Lunari), attraverso «un’atmosfera luminosa, mobile, impalpabile». Il giardino non solo è bianco, come lo vede Čechov dalle finestre della casa, ma è protagonista, è il sentimento che domina e pervade tutto, il dolore di chi lo perde e la gioia febbrile, la realtà di sogno di chi lo acquista. Per cui non basta indicarlo realisticamente con sagome d’alberi che si vedono dalle finestre del fondo. Portato alla massima astrazione di sentimento e pensiero, esso diventerà, nella invenzione scenografica di Luciano Damiani, un velario di seta trasparente sospeso sul palcoscenico come il tetto ondulato di un aereo baldacchino. Esso si muove e respira come una nuvola, e ogni tanto, quando è percorso dall’onda del movimento, foglie d’albero, che si vedono in trasparenza, cadono volteggiando sul palcoscenico o sulle prime file di poltrone. Qualche pio spettatore le raccoglie e le mette nel taschino o nella borsetta. Il rito si compie da solo, senza imposizioni.
[…] Il bianco è innanzitutto il colore della vittima sacrificale, l’immagine del giardino che deve essere abbattuto. È anche il colore della purezza; purezza delle cose, natura e oggetti, che saranno cancellati dalla trasformazione fondiaria. Ma è soprattutto – e qui l’intuizione da analogica diventa metafisica – il colore dell’innocenza. Non ci sono colpevoli o malvagi, nel Giardino, ed è come dire nell’umanità, perché ogni opera è una piccola ma compiuta immagine del mondo. Non sono colpevoli i vecchi proprietari del ciliegeto, Gajev e sua sorella Liubov, ridotti in miseria dalla loro inettitudine, dall’educazione all’ozio e costretti a vendere all’asta la proprietà. Inetti ma dolci, il piccolo retore remissivo Gajev, la inquieta e scriteriata Liubov. La storia si incarica di emarginarli, e infatti sono come due bambini, regrediti all’età dell’innocenza perfetta, l’infanzia, e ormai fissi in essa. La stanza dei bambini, dove avvengono il primo e l’ultimo atto, arredata con due piccoli banchi di scuola e un immenso armadio, che, aprendosi, rigetta in scena giocattoli e una carrozzina nera, piccola ma straziante immagine funeraria del bambino di Liubov annegato nel lago, è un altro punto di forza dello spettacolo e si integra perfettamente nel bianco; il quale, dicevo, è il colore di un’umanità che erra, ma non pecca; infatti non è colpevole neanche Lopachin, il contadino arricchito dalla mercatura, che acquista il ciliegeto e sarà padrone dove una volta ha servito. […] Tutti sono innocenti e tutti egualmente soffrono di un dolore che non si attenua, tanto è connaturato al fatto stesso di esistere. Questa è la filosofia di Čechov. Il tempo passa, esseri umani tramontano, altri ne sorgono. E tutto nel bianco di una dolce, indifferente innocenza.
[…] Sarà difficile in avvenire disgiungere, nel ricordo, il testo di Čechov dalle immagini di questo spettacolo nel quale si centrano i termini di un discorso sulla mutazione, cioè sulla storia, l’innocenza e il dolore, condotto con la capacità di penetrazione che ha l’arte.Giorgio Prosperi, “Il Tempo”, 25 gennaio 1976
- Čechov sul piccolo schermo
In quest’aria di cataclisma celeste, dove a incombere è più la notte del giorno (stupendo il ventaglio di sbadigli con cui i personaggi animano l’esordio), in questo chiaroscuro che ci avverte come un faro intermittente dell’agonia dei sentimenti borghesi, l’immagine meccanica e quella scenica si favoriscono a vicenda, fondendo analisi e descrizione, totali e dettagli, stacchi e sequenze lunghe, per cui possiamo a nostra volta avvertire: è cinema! E il telespettatore si sente avvolto da quel senso di stanche carezze con cui l’anima della borghesia russa prende congedo dai corpi dei suoi sopravvissuti, trasalendo alla minacciosa corporeità degli affaristi: sciacalli sulle sue ceneri.
Dell’edizione strehleriana varata nel ’74, il mezzo televisivo evidenzia questo aspetto fondamentale: la trepidazione; uno stato d’animo che, in video, si fa stato di scena, e noi vi avvertiamo un esasperato addio dei sensi, il dramma di ciò che è sottinteso, una mescolanza di affetto e cinismo che creano l’ambiguità, la sensazione di stare sempre sul punto decisivo mentre – perfettamente “ripresi” oltre che “inscenati” – sempre intervengono nei personaggi lo scatto regressivo, il brusco rifiuto.
Quanto utile è stata la presenza delle telecamere, anche a stimolare la genialità di Strehler, lo dimostrano due episodi: nel primo, De Carmine, che interpreta Gaev, si trova di fronte all’armadio che contiene i ricordi di una vita, maldestramente lo abbatte, e dal simbolico ventre s’abbatte su di lui il gaddiano viscerame, alla fine non restando che il correre infantile di un trenino, lo stesso che più avanti solcherà l’orizzonte portandosi l’inutile sogno di fuga dei protagonisti; nel secondo, l’elegia della ribalta è spezzata, offesa, dall’irruenza del viandante, interpretato da Nikolaev: egli parla il russo, ma gli altri non sembrano capirlo, restano attoniti come di fronte a un linguaggio sconosciuto.
È uno dei momenti di più alta poesia, con il viandante che scompare nella platea deserta, portandosi il carico ancora psicologicamente primordiale, e quasi animalesco, della nuova Russia popolare che Ljubov Andreevna e lo stesso Lopachin non potranno mai intendere, soltanto subire o sfruttare.
Ma altri cento segni hanno provato che Strehler e il visivo (cinema, televisione), questi due amanti in potenza che continuano a non consumare il loro rapporto, raggiungerebbero – unendosi – rilevanti risultati di ricerca e di stile. Il regista insiste a chiudersi nell’alveo della sua disciplina, tuttavia è chiaro che non cessa d’essere provocato delle nostalgie della cultura cinematografica e dalle tentazioni dell’immagine filmica.
Nel televisivo Giardino, gran parte degli attori si è aggirata, con accortezza stilistica, usando una diversa intensità recitativa, adeguata ai campi ravvicinati dell’obiettivo; tra i più efficaci, nell’agevolare la sintesi del doppio linguaggio, il Firs reso da Ricci, e poi De Carmine e un Graziosi in gran forma, la Lazzarini e il Fattorini, oltre al Nikolaev di cui s’è detto: lampeggiante quanto non trascurabile portatore di destino.Alberto Bevilacqua, “Corriere della Sera”, 26 marzo 1978